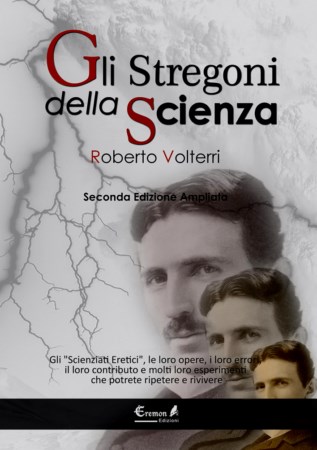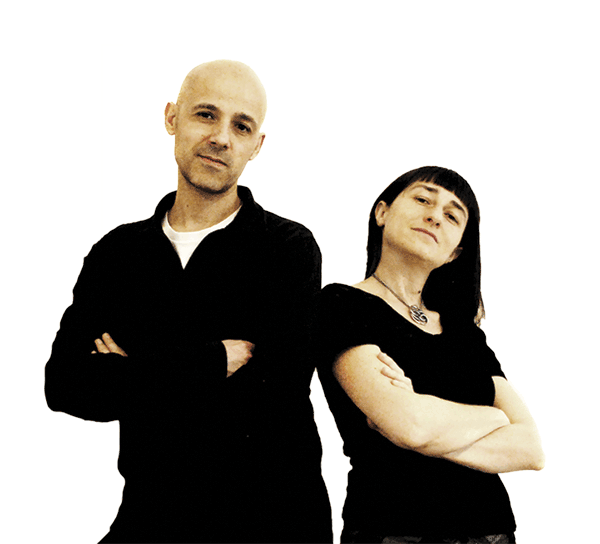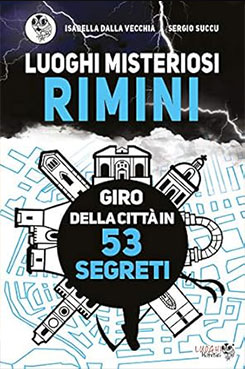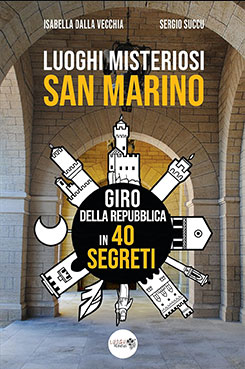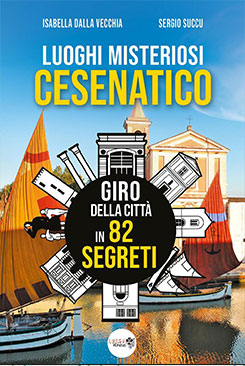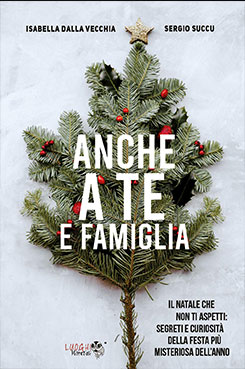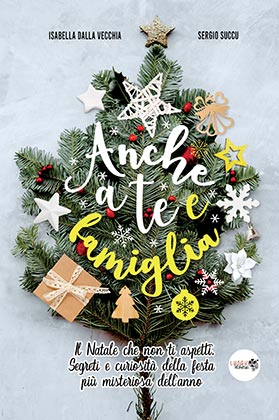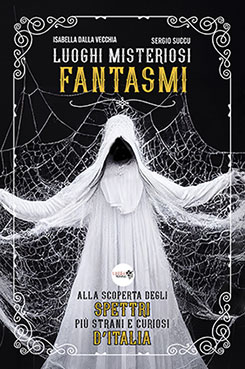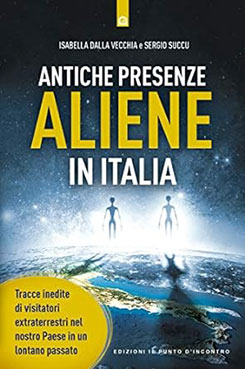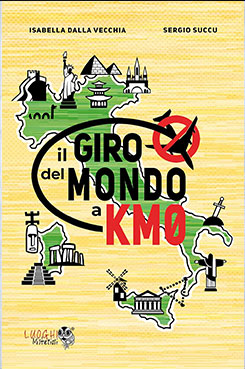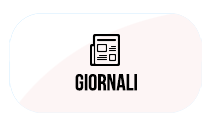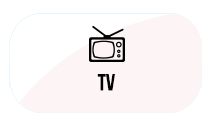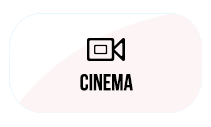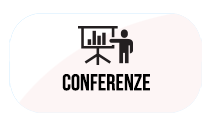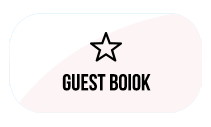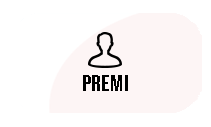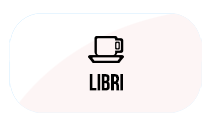![]() Accademia di agricoltura, scienze e lettere – Via Leoncino, 6, 37121 Verona / ‘Orologi perpetui’ da essi realizzati sono tuttora conservati presso il Liceo ‘Scipione Maffei’ di Verona. Sembra che siano stati revisionati, poiché un tempo non funzionavano a causa dell’assenza delle indispensabili ‘pile’
Accademia di agricoltura, scienze e lettere – Via Leoncino, 6, 37121 Verona / ‘Orologi perpetui’ da essi realizzati sono tuttora conservati presso il Liceo ‘Scipione Maffei’ di Verona. Sembra che siano stati revisionati, poiché un tempo non funzionavano a causa dell’assenza delle indispensabili ‘pile’

L’OROLOGIO ETERNO DELL’ABATE ZAMBONI

ARTICOLO E FOTOGRAFIE DI ROBERTO VOLTERRI volterri@mec.uniroma2.it
__________________________
CATEGORIE
curiosità
Inspiegabile
Oggetti (nvenzioni)
Personaggi
Tecnologie del passato
“O speculatori dello continuo moto…
quanti vani disegni in simile cerca avete creato!”
Sagge parole del grande Leonardo da Vinci. E se lo dice lui che non si fermava davanti a nessuna difficoltà…
In questo articolo dedicato alle infinite stranezze dell’umano ingegno e a qualche altra scienza ancora da inventare, non possiamo dimenticare il ‘Moto Perpetuo’ – il leonardesco ‘continuo moto’ – indistruttibile sogno di qualsiasi mente più o meno balzana, che abbia cercato di lasciare un’indelebile traccia nel lungo e periglioso cammino della Conoscenza.
Spesso – per non dire sempre – chi ha cercato imperitura gloria nella vana speranza di realizzare davvero un ‘Moto Perpetuo’ dietro di se ha lasciato solo qualche ironico commento, qualche risolino di compatimento da parte della cosiddetta ‘scienza ufficiale’ e salaci considerazioni sull’umana stoltezza.
Ma non è ancora detta l’ultima parola…
Però, in alcuni casi, qualcuno si è avvicinato ad una soluzione che presenta una stretta
parentela con almeno una delle tre ‘classi’ con cui di solito viene suddiviso il concetto di “… Machina controversa numquam obtineri posse motum perpetuum…” ovvero di un discutibile dispositivo da cui mai si potrà ottenere un movimento che duri all’infinito, per usare le illuminanti parole di Jacques Bernoulli (1654 – 1705), matematico e fisico svizzero appartenente alla vasta stirpe dei Bernoulli, scienziati di chiara fama.
In effetti ci sarebbe più di un ‘Moto perpetuo’.
Quello di ‘Prima classe’ dovrebbe essere in grado di non recepire energia dall’esterno ed essere al contempo capace di produrne. La vedo ‘dura’…
Quello di ‘Seconda classe’ dovrebbe addirittura violare il principio di Entropia e anche il Secondo principio della Termodinamica che, secondo Clausius, sancisce come sia impossibile produrre una trasformazione il cui risultato sia quello di trasferire calore da un corpo più freddo ad uno più caldo.
Ma, se volessimo complicarci l’esistenza, potremmo riferirci anche a quanto stabilito da Lord Kelvin e Max Planck: è impossibile produrre una trasformazione ciclica il cui risultato consista nella trasformazione in lavoro di tutto il calore assorbito da una sorgente omogenea.
Non siete contenti? Allora ricorriamo sul serio e più direttamente al concetto di Entropia che stabilisce categoricamente come in un sistema isolato l’Entropia stessa – in parole povere, il disordine – sia una funzione non decrescente nel tempo.
E tutto ciò stabilirebbe proprio l’impossibilità a realizzare l’agognato ‘Moto perpetuo’ di ‘Seconda classe’ che contempla la non reversibilità dei processi termodinamici.
Infine, il ‘Moto Perpetuo’ di ‘Terza classe’ dovrebbe limitarsi – si fa per dire! – ad eliminare tutti gli attriti e far funzionare un qualsiasi dispositivo all’infinito, ma senza fornire ‘potenza’ all’esterno. Sembra facile, ma qualcuno ci ha provato e sembra esserci riuscito. Ora lo conosceremo…
LA STRANA PILA ELETTRICA DELL’ABATE GIUSEPPE ZAMBONI
Arbizzano, amena località della provincia di Verona. 1 giugno 1776.
Ai piedi delle colline veronesi nasce Giuseppe Zamboni, precoce ingegno avviato subito agli studi di filosofia e teologia, dato che l’entrare in seminario garantiva una solida preparazione culturale… con poca spesa.
A ventitre anni viene nominato abate e inizia ad insegnare filosofia nelle scuole di S. Sebastiano, non lontano da Verona. Teologia e filosofia a parte, la vera passione di Zamboni erano le scienze fisiche, anche se al ‘nostro’ mancavano nasi accademiche per comprendere a fondo alcuni fenomeni. Ma queste ‘carenze’, a volte, portano molto lontano…
.jpg)
l’abate Giuseppe Zamboni (1776 – 1846)
Tanto lontano che nel 1805 Zamboni viene incaricato di insegnare ‘Fisica sperimentale e matematica applicata’ presso l’Imperiale Regio Convitto di Verona, oggi ‘Liceo Classico Scipione Maffei’. Da quell’anno fino al 1815 Zamboni mette a punto delle pile elettriche, abbastanza simili a quella di Alessandro Volta, che poi gli serviranno, negli anni successivi, per realizzare quelli che ora sono noti come ‘Orologi eterni’ in quanto sembrano funzionare da lunghissimo tempo senza alcun apparente apporto di energie esterne.
Almeno uno pare ancora funzioni da 150 anni presso il Cavendish Laboratory, ad Oxford!
In realtà il ‘nostro’ Zamboni stava lavorando da alcuni anni alla messa a punto di ‘pile elettriche’ migliori di quelle presentate al mondo scientifico dal comasco Alessandro Volta.
.jpg)
la classica, originale, ‘Pila di Volta’
La ‘pila’ voltiana è costituita da un alternarsi di dischi di rame e di zinco, separati da un isolante imbibito di opportuno elettrolita (acido solforico diluito). Proprio sotto l’azione dell’acido lo zinco si consumava. Ma l’acido solforico è essenziale al fine di evitare la cosiddetta ‘polarizzazione’ della pila che avrebbe inesorabilmente portato al cessato funzionamento della stessa.
.jpg)
lo scienziato comasco mostra a Napoleone il funzionamento della sua invenzione
La ‘pila’ voltiana è costituita da un alternarsi di dischi di rame e di zinco, separati da un isolante imbibito di opportuno elettrolita (acido solforico diluito). Proprio sotto l’azione dell’acido lo zinco si consumava. Ma l’acido solforico è essenziale al fine di evitare la cosiddetta ‘polarizzazione’ della pila che avrebbe inesorabilmente portato al cessato funzionamento della stessa.
Dopo mille esperimenti, Zamboni evita questi inconvenienti realizzando delle ‘pile a secco’ che eliminano l’uso di elettroliti troppo aggressivi nei confronti dei due metalli che le costituivano.
“… la colonna voltiana infatti – per usare le parole dello stesso Zamboni – per l’ossidamento de’ due metalli bagnati dalla soluzione acida e salsa, portava seco il germe della propria sua distruzione. Conduttore solido non poteva mettersi in luogo dell’acqua, che la sua forza elettromotrice avrebbe guastato: ciò appunto diceano espresso i principi teorici e gli studi sperimentali del Volta. Ma fra i corpi che, per contenere in sé alcuna traccia di umidità, danno qualche passaggio al flusso elettrico senza tuttavia nuocere ai metalli, era bene e non forse indarno cercare. E la tensione intanto (uscita quasi altrui di vista per la sua tenuità) non avrebbe potuto, pel men perfetto ufficio del conduttore, farsi a più doppi ingrandire sino a trarne qualche nuovo utile effetto?”.
Qualche esperimento per eliminare o almeno sostituire adeguatamente l’elettrolita era già stato tentato, ad esempio, sia da Jean André De Luc che da Jean-Baptiste Biot, il quale aveva impiegato una soluzione di nitrato di potassio, meno corrosiva.
.jpg)
.jpg)
sopra Jean André De Luc e sotto Jean-Baptiste Biot, i due scienziati che prima di Zamboni avevano effettuato esperimenti per eliminare la corrosione degli elettrodi
Zamboni elimina del tutto gli acidi corrosivi e vede che le sue pile, costituite da circa duemila dischetti di ‘carta d’argento’ su cui poggiavano altrettanti sottilissime lamine di una lega binaria di rame e zinco – di solito usata in oreficeria e per decorare strumenti musicali – denominata ‘tombacco’.
Tra uno strato metallico e l’altro Zamboni spalma un sottile sostanza organica che isola un dischetto dall’altro. Sulla carta d’argento egli deposita poi una pasta realizzata con polvere di carbone e acido nitrico diluito in acqua.
E l’elettrolita vero e proprio dove stava?
Forse Zamboni stesso ancora non lo sa, ma l’elettrolita si forma proprio grazie alla sempre presente umidità atmosferica che interagisce con le sostanze depositate sui numerosissimi dischetti metallici.
Dopo numerosi contatti epistolari con il Volta, egli usa anche solfato di zinco disciolto in acqua oppure ossido di manganese sciolto in acqua e colla d’amido, miele oppure olî vari. La lunga serie di dischi veniva poi ricoperta con strati di pece greca, cera e vernice isolante. Veniva infine introdotta in un tubo di vetro.
.jpg)
A sinistra, una ‘Pila di Volta’ e a destra la ‘Pila di Zamboni’. Come si vede sono molto simili, ma in quelle dell’abate veronese la ‘soluzione elettrolitica’ si formava naturalmente, grazie all’assorbimento dell’umidità atmosferica da parte dei dischetti che isolavano le numerosissime lamine metalliche
Le ‘pile a secco’ di Zamboni generano una consistente differenza di potenziale (leggasi ‘tensione’) ma forniscono solo correnti di debolissima intensità. Il fenomeno della ‘polarizzazione’ avviene ugualmente ma in tempi estremamente lunghi. Una volta che la carica si sia considerevolmente affievolita, basta la presenza di una minima percentuale di umidità atmosferica per ripristinare la presenza dell’elettrolita e per ‘ricaricare’ la pila. Ciò impone di non inserire le pile in un contenitore ermeticamente stagno rispetto all’ambiente esterno – insomma in una campana di vetro – ma è necessario introdurle in un tubo di vetro in cui possa fluire liberamente l’aria circostante. In seguito Zamboni applica le sue pile ‘eterne’ (o quasi) ad un semplice meccanismo che funge da orologio.
Chiama Elettromotore perpetuo la sua invenzione e ne mette in funzione una presso l’Istituto di Fisica dell’Università di Modena. É il maggio del 1839 e l’orologio non si ferma per oltre un secolo. Se non è un vero e proprio ‘moto perpetuo’… poco ci manca!
.jpg)
Oltre a quella di Volta e di Zamboni, molte altre sono le ‘pile’ atte a generare elettricità a bassa tensione. Quella qui raffigurata è una ‘Pila Leclanchè’, realizzata nel 1874 con un vaso di vetro, riempito con una soluzione di cloruro di ammonio (NH4Cl), in cui sono immersi un elettrodo di zinco e un cilindretto poroso che contiene una barra di carbone circondata da biossido di manganese (MnO2).

Di Carlo Vannini/Museo Civico di Modena, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95087036
Un ‘Orologio eterno’ di Zamboni
L’Elettromotore perpetuo viene realizzato con un leggero pendolo che può oscillare tra due elettrodi collegati alle ‘pile a secco’ che fin qui abbiamo incontrate.
La parte oscillante, in materiale conduttore di elettricità, si sposta quindi tra i due elettrodi ognuno dei quali presenta una polarità diversa dall’altro. Quando il pendolo si avvicina all’elettrodo positivo (+) e lo tocca, esso si carica con la stessa polarità e, poiché cariche uguali si respingono, si allontana dall’elettrodo stesso e tende ad avvicinarsi all’altro elettrodo, negativo ( – ).
Non appena lo tocca, il pendolo si carica negativamente, si ripete il meccanismo d’azione prima descritto e così… all’infinito (o quasi).
Da tale ‘Elettromotore perpetuo’, ovviamente, non ci si può aspettare una cronometrica precisione!
Infatti, nel 1839 le oscillazioni al minuto erano pari a 95, mentre quasi un secolo più tardi si erano dimezzate per poi risalire a 60 oscillazioni dopo un tempo necessario alle pile per ricaricarsi grazie all’umidità atmosferica assorbita.
Zamboni, però, non ha molta manualità e pertanto ricorre al preziosissimo aiuto di un tecnico del laboratorio di Fisica del Regio Liceo ove il nostro scienziato insegna.
Carlo Streizig, infatti, è anche un validissimo orologiaio e realizza senza troppe difficoltà la parte prettamente meccanica dell’orologio.
Zamboni, i seguito, si avvale anche della collaborazione dell’orologiaio Giovanni Bianchi e del tecnico veronese Antonio Camerlengo, il quale “… trovò il modo di far servire la potenza del pendolo oscillante fra le colonne elettromotrici a caricare l’orologio; ritrovamento che così all’Accademia che gli fé dono d’una medaglia del valore di 30 Zecchini. L’orologio è in continuo moto, e potete esaminarlo nel gabinetto fisico, ove però il troverete ora assai più esatto per nuove aggiunte del solertissimo Zamboni.”, ricordano gli Atti dell’Accademia di Agricoltura, Commercio e Arti di Verona, pubblicati nel 1824.
‘Orologi perpetui’ da essi realizzati sono tuttora conservati presso il Liceo ‘Scipione Maffei’ di Verona. Sembra che siano stati revisionati, poiché un tempo non funzionavano a causa dell’assenza delle indispensabili ‘pile’…
Fino al 1930 ne funzionava uno – da un secolo! – anche presso Il Museo di Storia della Fisica dell’Università di Padova.
Pure il grande fisico francese Arago, ha modo di apprezzare pubblicamente gli studi e le esperienze del geniale veronese poiché, in un discorso tenuto il 29 novembre 1830 presso l’Accademia delle Scienze di Parigi, così esordisce “…In fatto di moto perpetuo nulla mai si farà di meglio del grazioso istrumento inventato dal signor Zamboni, il cui principio motore è l’elettricità delle pile conosciute col nome di pile a secco. Un piccolo corpo leggero sospeso ad un filo di seta tra i due poli di queste pile, è continuamente attratto e respinto dall’elettricità.”
Non solo i grandi della Fisica, dell’Elettrologia nascente apprezzano gli esperimenti di Zamboni, anche i suoi studenti lo ammirano e prendono molto diligentemente curiosi, divertenti e policromi appunti…
.jpg)
.jpg)
Due divertenti appunti presi a metà dell’Ottocento da studenti dello Zamboni
Che dire?
Era il misconosciuto abate Zamboni alle soglie di una scoperta che poi lo avrebbe condotto veramente verso la ricerca di quell’Araba Fenice che definiamo ‘Moto Perpetuo’? Direi di no, però è estremamente interessante frugare negli archivi della Storia alla ricerca di geniali tentativi per dar vita a strani meccanismi che ‘dal nulla’ traggano fonte di energia per funzionare in eterno (o quasi!).
Zamboni, comunque, oltre ad essere uno spirito vivace era anche uomo… di spirito poiché così ebbe modo di commentare, autoironicamente, la sua invenzione…
“Se ciò che non è eterno è un ben niente
e questo ordigno mai non si riposa
si potrà dire ch’egli solamente
in mezzo a tanti nulla è qualche cosa”.
A Verona, in via Pietà Vecchia, l’abate Giuseppe Zamboni abitò fino alla fine dei suoi giorni. Oggi questa lapide ricorda questo geniale, quasi misconosciuto scienziato
Per i lettori interessati allo sviluppo delle ricerche sull’elettricità ai tempi di Alessandro Volta suggerirei di visitare il TEMPIO VOLTIANO, Museo scientifico situato a Como, sul Lungo Lario Guglielmo Marconi, 1- Tel. 031-574705
Per continuare i viaggi tra i misteri della Storia…
Ordina il libro
Gli scienziati eretici, le loro opere, i loro errori, il loro contributo e molti loro esperimenti
Nikola Tesla, Giuseppe Calligaris, Ferdinando Cazzamalli, Raffaele Bendandi, Marco Todeschini, Guido Cremonese, Pierluigi Ighina e vari altri ‘eccentrici’ ricercatori. Cosa hanno in comune questi personaggi? Essi, senza dubbio alcuno, potrebbero essere considerati degli ‘stregoni’ della Scienza, forse degli eretici ‘geni incompresi’, in bilico tra la tecnologia e la scienza di stretta osservanza e quegli affascinanti territori di confine dove una creativa ‘follia’ si sposa – spesso con incredibili risultati! – con ciò che già sappiamo dell’Universo che ci circonda.
Il sito dei misteri
www.luoghimisteriosi.it – info@luoghimisteriosi.it


.jpg)
.jpg)