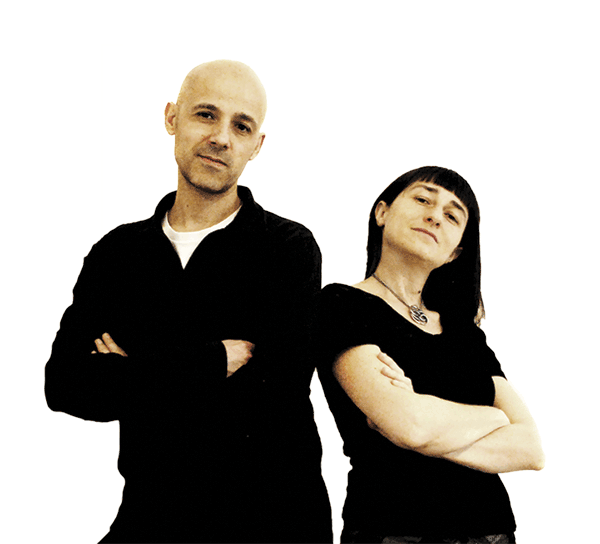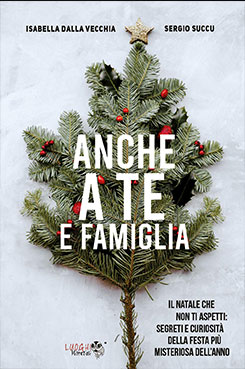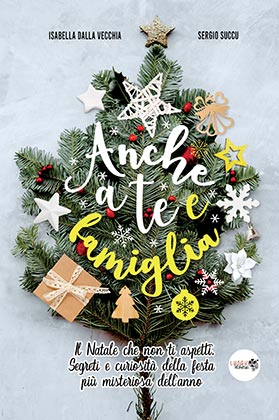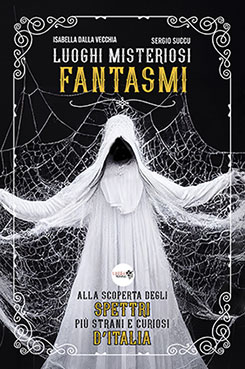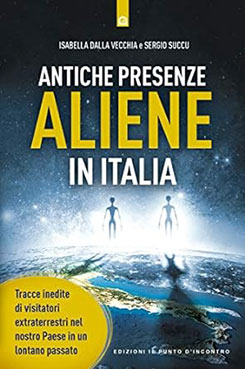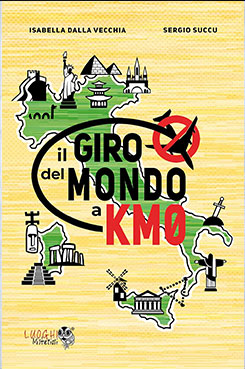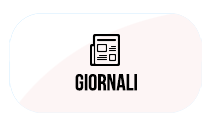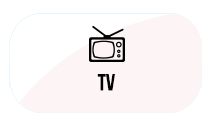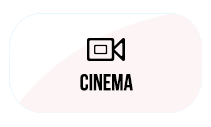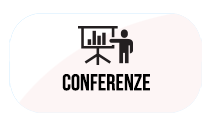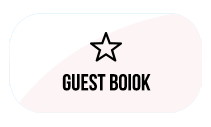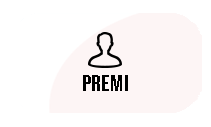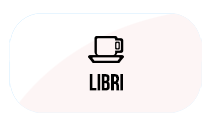![]() ALATRI (FR) – CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO / Si tratta di un affresco che raffigura un “Cristo in Gloria” al centro di un enorme labirinto di dodici cerchi concentrici neri ed altrettanti bianchi.
ALATRI (FR) – CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO / Si tratta di un affresco che raffigura un “Cristo in Gloria” al centro di un enorme labirinto di dodici cerchi concentrici neri ed altrettanti bianchi.
IL MISTERO DELL’AFFRESCO CON IL “CRISTO NEL LABIRINTO”

ARTICOLO E FOTOGRAFIE / Giancarlo Pavat
con la collaborazione di Sonia Palombo
__________________________
CATEGORIE
COINCIDENZE
ENIGMI SU GESU’
FIGURE RARE
INSPIEGABILE
PERCORSI INIZIATICI
TEMPLARI
Simbolo: CROCE PATENTE
FIORE DELLA VITA
LABIRINTO
Luogo: GALLERIE
Quale filo misterioso lega la citta’ di Alatri alla cattedrale di Chartres in Francia?
Alatri è una splendida cittadina della Ciociaria (provincia di Frosinone) abbarbicata sui rilievi della catena che prende il nome dagli antichi abitanti italici del territorio; gli Ernici.
La località, pur essendo famosa soprattutto per le incredibili mura in opera poligonale che la leggenda vuole erette o dai ciclopi, o dal dio Saturno o dal misterioso popolo dei Pelasgi, vanta ulteriori e numerose emergenze artistiche e monumentali sia di epoca romana che medievale.
Rientra proprio in quest’ultima categoria, l’opera d’arte di cui desidero parlare, che si presenta come un vero e proprio unicum; non essendo nota, al momento, alcuna rappresentazione simile in tutto il Mondo.
Si tratta di un affresco che raffigura un “Cristo in Gloria” al centro di un enorme labirinto di dodici cerchi concentrici neri ed altrettanti bianchi.
.jpg)
Affresco con il Cristo nel Labirinto
Tornò alla luce negli ultimi giorni del 1996, quando gli alatrensi Ennio Orgiti, Orestino Fanfarilli, all’epoca presidente della Pro Loco ed il presidente dell’APT Paride Quadrozzi, nel tentativo di individuare l’origine dei pestiferi vapori che ammorbavano gli ambienti del Chiostro di San Francesco, adiacente all’omonima chiesa duecentesca, si ritrovarono in una sorta di cunicolo. Dove con le torce elettriche illuminarono l’inconsueto apparato pittorico.
.jpg)
Labirinto di Alatri – Ingresso
Se ne parlò per qualche tempo sulla stampa quotidiana ciociara ma poi, come spesso accade, tutto scivolò nell’oblio e del misterioso affresco non se ne seppe più nulla.
A rompere parzialmente questo muro del silenzio intervenne, nel 2002, Gianfranco Manchìa direttore del Civico Museo alatrense, con un articolo “Cristo nel labirinto: comunità giudeo-cristiana o presenza Templare?” pubblicato su “Antichità Alatrensi. – Quaderni del Museo Civico di Alatri. – Assessorato alla Cultura”.
Ma le controverse ipotesi avanzate dallo studioso non riuscirono a gettare luce sugli enigmi che avvolgevano ed avvolgono l’affresco.
.jpg)
Pavat nel cunicolo del labirinto
A QUALE EPOCA RISALE?
CHI L’HA REALIZZATO E PERCHE’?
SI TRATTA DI UN OPERA CRISTIANA ORTODOSSA OPPURE, COME SOSTENUTO DAL MANCHIA ABBIAMO DAVANTI LA TESTIMONIANZA DI UNA PRESENZA ERETICALE?
ED INFINE CHE COS’ERA L’AMBIENTE CHE OGGI CI APPARE COME UN CUNICOLO, O MEGLIO INTERCAPEDINE?
Quesiti che continuano a togliere il sonno ed a tormentare le menti dei ricercatori più sensibili, soprattutto alatrensi, ma non solo. Consci della sua unicità e del suo valore non soltanto artistico.
L’impenetrabilità di questo mistero ha fatto si, che alcuni, pur di non rischiare le proprie carriere, abbiano deciso deliberatamente di ignorare l’affresco. Come se non fosse mai esistito.
Ed invece esiste. Silente testimone dei sentimenti, dei pensieri, delle aspirazioni, delle speranze, della Conoscenza, della Fede, di qualcuno che ci ha preceduto. Lasciandoci un messaggio.
.jpg)
Pellegrini Forgione e Pavat all’uscita del cunicolo
Nel marzo del 2007, mentre stavo correggendo le bozze del mio libro sulla presenza dei Cavalieri Templari nel Basso Lazio (volume frutto di oltre due anni di ricerche sul campo, che poi uscì nel novembre successivo con il titolo “Valcento. Gli Ordini Monastico-cavallereschi nel Lazio Meridionale”, Edizioni Belvedere di Latina), l’avvocato Remo Costantini, che mi onora della sua amicizia e che all’epoca ricopriva la carica di assessore alla cultura della sua città, sapendo dell’argomento dei miei studi, e ritenendo che potessero avere a che fare con l’affresco, mi invitò a visitare il chiostro.
Organizzai una ”mini spedizione” assieme al prof. Italo Bidditu (famoso per aver scoperto nel febbraio del 1994, presso Ceprano in Ciociaria, i resti del più antico ominide europeo. Poi ribattezzato “Argil” , datatati al oltre 800.000 anni fa), la storica dell’arte dottoressa Alessandra Leo e mia moglie Sonia, ed equipaggiati con materiali da speleologo (altra mia passione sin da ragazzino), penetrammo nel cunicolo. Rimanendo sconcertati da quello che ci trovammo di fronte.
Dentro un cunicolo, sopra una parete volta a mezzogiorno, campeggiava l’affresco con il Labirinto ed il “Cristo in Gloria”.
Il Labirinto, simbolo antico come la stessa Umanità. Rintracciabile tra le iscrizioni rupestri della Val Canonica. Nelle Isole Britanniche, in Francia, in Sardegna, a Pompei. Ma pure in Medio Oriente come in Cina. Senza scordare le Civiltà ed i Popoli Precolombiani. Dal Perù all’Arizona, al New Mexico.
La mitologia classica ci ha lasciato il ricordo di quello, probabilmente il più famoso di tutti, dell’isola di Creta. A Cnosso. Costruito dall’architetto Dedalo per rinchiudere il mostruoso Minotauro. Essere antropofago, metà toro e metà uomo, nato dagli insani amori tra Pasifae, moglie di Minosse Re di Creta, ed uno splendido toro bianco, dono di Poseidone. Secondo il mito, il mostro divorava, ogni anno, sette fanciulli e sette fanciulle. Spaventoso tributo cui era sottoposta Atene, sconfitta in guerra da Minosse. L’eroe Teseo, figlio di Egeo, re della Città della dea con l’Egida, sbarcato sull’isola, riuscì nell’impresa di uccidere il mostro e di uscire dal labirinto grazie all’aiuto di Arianna, figlia di Minosse, e del suo celebre “Filo”.
Gaio Secondo Plinio, detto “Il Vecchio” (23-79 d.C.), nella sua celebre “Naturalis Historia”, vera e propria enciclopedia del Mondo Romano, ci narra di tre labirinti. Uno sull’isola di Lemno, uno eretto dal re etrusco Porsenna ed, infine, quello voluto dal Faraone Egizio Amenemhat II, attorno al 1797 a.C., presso il Lago Meride. Anche Strabone, secoli dopo rimase a bocca aperta davanti ad una simile meraviglia.
Nel Medio Evo, riprendendo Plinio, ne parlarono, nelle rispettive opere; “Etymologiae” (Libro XV, c. 36) ed il “De Universo” (Libro XIV, c. 12), sia Isidoro di Siviglia (560-636 d.C.) che Rabano Mauro (780-856 d.C.).
Ma il labirinto, ormai entrato a pieno titolo nell’universo simbolico cristiano, mutuato della classicità, andò a decorare i pavimenti delle grandi chiese e cattedrali gotiche nell’Europa Occidentale.
Le francesi Sens, Reims, Poitiers e Bayeux, solo per citarne alcune. Questi labirinti erano i “Cammini Gerosolimitani”, percorsi simbolici del pellegrinaggio in Oriente. La via che il pellegrino percorreva per raggiungere il centro, rappresentava la ricerca della Verità, della Fede. Metafora della stessa esistenza dell’Uomo. E’ la tetra “Selva Oscura”, allegoria del Peccato e dell’Ignoranza, ove si smarrisce Dante all’inizio del suo immortale Poema.
Senza scordare i labirinti rinascimentali. Sul soffitto ligneo del Palazzo Ducale dei Gonzaga a Mantova. O quelli in bosso di Villa Pisani a Stra e del giardino Barbarico di Valsanzibio, entrambi in provincia di Padova e quello di Palazzo Giusti a Verona.

Il labirinto alatrense ha il diametro del cerchio più esterno di poco meno di due metri. Quello del cerchio più interno è di 75 centimetri.
Nel dipinto Cristo ha il volto barbuto ed il capo è circondato da una aureola all’interno della quale si intravede una croce. Indossa una tunica ed un mantello dorato. Con la mano sinistra, al cui dito anulare porta un anello, regge un libro chiuso, collocato quasi in corrispondenza del cuore. Con la destra, invece, stringe un’altra mano che esce dal labirinto stesso.
.jpg)
Affresco del Cristo nel labirinto
L’immagine del “Cristo storico” non è attestata prima del IV secolo d.C.. Da ricordare, infatti, che nei primi secoli del Cristianesimo, Gesù non venne mai raffigurato nelle sue sembianze umane. Subendo ancora l’influsso della religione ebraica, che vieta le immagini, i primi seguaci della nuova Religione, preferirono rappresentarlo mediante simboli ed allegorie. Come la figura del “Buon Pastore“, che reca sulle spalle una pecorella e simboleggia Gesù salvatore delle anime. Oppure quella di un giovane imberbe, ad indicare la dimensione di Essere “Senza Tempo”, quindi Eterno e Divino.
Ed ancora, la “Colomba”, “l’Orante”, che tra l’altro con le braccia aperte ricorda la “Croce del Tau”, oppure “l’Ancora”, “l’Alfa e l’Omega” che sono rispettivamente la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco. Ma pure il disegno di un “pesce” (in greco pesce si dice IXTHYS, “Ichtùs”. E con queste lettere si forma un acrostico della frase “Iesùs Christòs Theòu Uiòs Sotèr”, ovvero “Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore”). Infine, il “Monogramma di Cristo”, formato dalle lettere greche “Chi” e “Rho”.
La tradizione vuole che l’Imperatore Costantino, nel 312 d.C., prima della decisiva Battaglia di Ponte Milvio contro l’usurpatore Massenzio, abbia sognato un angelo che recava una Croce, secondo altri avrebbe visto nel cielo un simbolo fiammeggiante, che altri non era che il “Monogramma di Cristo” con la celebre scritta “In hoc Signo Vinces”. Costantino fece apporre il “Monogramma”, composto appunto dalle due lettere greche, sui labari e sopra gli scudi. Ove rimase per secoli come insegna delle Armate Bizantine.
La grandezza del dipinto ed il fatto che sia posto in alto, lascerebbero intendere che sia stato realizzato per essere visto da una certa distanza. Quindi, in quel giorno di primavera, ci trovavamo in un sito che, originariamente, non era di certo una angusta intercapedine. Il muro affrescato potrebbe essere quello terminale di una vasta sala. “Probabile edificio di culto precedente all’edificazione della chiesa e del relativo chiostro di San Francesco. Di questo edificio si riconoscono elementi della facciata nei muri perimetrali a ovest del complesso architettonico del chiostro”. Come ha scritto Manchìa nella sua monografia del 2002. La chiesa risale alla seconda metà del XIII secolo, edificata ad opera dei Frati Francescani, presenti già da alcuni decenni ad Alatri. L’interno ha subito trasformazioni barocche nel XVII secolo. Dentro un urna di fattura anch’essa barocca, si conserva un mantello di forma e manifattura medioevale, che la tradizione locale, ma non le fonti, attribuisce a San Francesco d’Assisi.
Di certezze, quindi, nemmeno l’ombra.
Per questo motivo decisi di continuare a svolgere ricerche e studi nel tentativo di saperne di più, di fare un po’ di luce su questo misterioso affresco. Negli anni seguenti, sono ritornato spesso nel chiostro, sempre grazie alla disponibilità ed alla cortesia del sindaco dottor Costantino Magliocca, dell’Assessore alla Cultura dottor Giulio Rossi e del dirigente dottor Antonio Agostini.
Ne ho parlato in numerosi articoli su quotidiani, periodici, monografie, siti internet e, ovviamente, nel libro “Valcento”. Suscitando interesse, polemiche, nuove teorie. Sino alla clamorosa scoperta dell’inverno del 2009. Scoperta che ha, finalmente, catturato l’interesse degli organi di informazione a livello nazionale, come RaiUno ed il programma di RaiDue “Voyager” di Roberto Giacobbo, oppure il mensile “Fenix”, diretto da Adriano Forgione, ma soprattutto degli Enti deputati alla conservazione e valorizzazione del sito.
Perché, ed è bene non dimenticarlo mai, l’intero ciclo pittorico ha urgente bisogno di un intervento di restauro, prima che scompaia per sempre.

Per questa serie di motivi, il sindaco Magliocca, ha voluto organizzare il 24 aprile 2009, un convegno per portare a conoscenza di un pubblico più vasto l’esistenza stessa di una simile opera d’arte e soprattutto per rendere pubblica l’ultimissima in ordine tempo) scoperta ad essa relativa, realizzata dal sottoscritto.
Sorta di “rivoluzione copernicana” che, come ha sottolineato con orgoglio il Primo Cittadino alatrense, “apre orizzonti di ricerca inaspettati”.
.jpg)
.jpg)
Tavolo dei relatori e pubblico del convegno del 24 aprile 2009
.jpg)
Dott.ssa Alessandra Leo – Sindaco Magliocca – G. Pavat
Come relatori sono stati invitati rappresentanti della cultura, non soltanto locale. La dottoressa Alessandra Leo, l’ing. Giulio Coluzzi, ricercatore indipendente e coautore, assieme a Marisa Uberti, del libro “I luoghi delle Triplici Cinte in Italia”, per i tipi della Eremon Edizioni, 2008, l’archeologo medievista Giuseppe Fort e Adriano Forgione.
.jpg)
Alessandra Leo illustra la storia del labirinto
Numeroso il pubblico che ha gremito l’Aula Magna dello storico Palazzo Conti-Gentili, affacciato sulla piazza S. Maria Maggiore di Alatri. Oltre ad autorità civili e militari, persino il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone Col. Giancostabile Salato, giornalisti ed altri appartenenti al mondo dei mass-media e moltissimi studiosi, docenti universitari, appassionati e semplici cittadini.
.jpg)
G. Pavat conclude la sua relazione al Convegno del 24 aprile
MA DI QUALE SCOPERTA SI TRATTA?
L’affresco si trova in una posizione decisamente scomoda per poterlo fotografare in maniera da ottenere immagini nitide, soprattutto dei suoi particolari.
Situazione che non aveva mai permesso di riportare su carta il tracciato del labirinto.
Almeno sino ad oggi. Ci sono riuscito, nella migliore tradizione dei romanzi gotici, in una fredda e tempestosa serata d’inverno.
Probabilmente non per merito mio, ma perché era giunto il momento affinché avvenisse.
Ingrandendo al computer le foto dell’affresco (scattate durante una ennesima “escursione” assieme a Tommaso e Nadia Pellegrini, Fabrizio Pennacchia, Daniele Palombi e Giulio Coluzzi), allo scopo di individuarne i dettagli, piano piano, come se fossero le tessere di un mosaico o di un puzzle, ho cominciato, pezzetto dopo pezzetto, a disegnare il percorso del labirinto su un foglio.
Ad un tratto mi sono bloccato. Il disegno che avevo tracciato sul foglio mi era famigliare. Mi ricordava un altro labirinto. Famosissimo. Presente in una cattedrale gotica altrettanto celeberrima.
Avevo davanti la pianta di quello che decora il pavimento della navata della Cattedrale di Chartres in Francia. Soltanto che io avevo disegnato quello di Alatri!!!!.
.jpg)
Ricostruzione del labirinto di Alatri – G. Pavat
.jpg)
Pianta del Labirinto di Chartres
Ho sovrapposto più volte i tracciati dei due labirinti. Prescindendo dalle dimensioni, in quello di Chartres il diametro del cerchio esterno è di dodici metri, e da alcuni particolari, che potremmo definire “licenze artistiche”, i percorsi dei due labirinti, quello verticale alatrense e quello pavimentale francese, sono identici.
.jpg)
Sovrapposizione dei due labirinti
Le differenze riguardano il fatto che quello di Chartres ha il cerchio centrale a forma di “rosa esalobata” (comunque simbolo “Cristico”), gli angoli arrotondati (mentre quello alatrense ha gli spigoli netti), ed una sorta di “ghiera dentata” decora il cerchio più esterno.
Un architetto francese del XIII, il piccardo Villard de Honnecourt, ci ha lasciato un notevole e davvero unico taccuino di appunti, conservato alla Bibliotheque Nazionale de France. Tra gli schizzi, in cui riporta figure umane, di animali, simboli, molti tratti da sculture e bassorilievi delle cattedrali gotiche, spicca la pianta del labirinto di Chartres, senza “rosa esalobata”, senza ”ghiera dentata” e con gli angoli non arrotondati”.
Ma dall’analisi del disegno sono emersi altri aspetti decisamente interessanti.
Innanzitutto l’andamento logico, quasi matematico, geometrico, del percorso. Ed è stata questa razionalità che ha permesso di ricostruire anche quei tratti scomparsi a causa del distacco dell’intonaco.
Dal disegno è emerso che il labirinto di Alatri ha un percorso “unicursale”, ovvero esiste una sola entrata ed un sola uscita al centro e per raggiungerla c’è un unica strada.
Come tutti i labirinti “unicursali”, lo scopo non è districarsi tra vari incroci, vicoli ciechi, corridoi che riportano sempre al medesimo punto (labirinto “multicursale”) bensì far percorrere una volta soltanto tutti i vari meandri. Voluta dopo voluta, il tracciato si avvicina e si allontana dal centro. Ritmicamente, quasi si trattasse di una danza, il sinuoso, armonico percorso conduce il viandante che vi entra, lungo un sentiero che potrebbe rappresentare l’allegoria del cammino della vita di tutti i giorni, ma pure dell’ardua ricerca della Verità con la lettera maiuscola. Che attende al centro e che ad Alatri è rappresentata da Cristo. I dodici cerchi concentrici neri rappresentano le muraglie (dobbiamo infatti immaginarci il labirinto come una struttura tridimensionale) che delimitano i corridoi; undici più il cerchio centrale, quello dove si trova il Cristo, tutti di colore bianco.
Aumentando la definizione delle foto ho scoperto pure il metodo utilizzato per realizzarlo. L’artefice ha tracciato prima la circonferenza centrale e le altre 23 ad essa concentriche. Il risultato doveva essere simile ai cerchi, altrettanto concentrici, della volta della cupola della “Rotonda” della “Spada nella Roccia” di Montesiepi. Poi, prima di colorarle di nero e di bianco, ha “tagliato” le circonferenze, creando angoli, meandri e corridoi. Dando al labirinto un aspetto cruciforme. A qualcuno ricorda una “Croce patente”, come quella presente sulla controfacciata di San Francesco, di cui si parlerà più avanti.
Si è già evidenziato come la parete affrescata sia rivolta a mezzogiorno. Quindi l’entrata del labirinto si trova ad occidente (alla sinistra di chi l’osserva) e l’uscita è rivolta ad oriente. In pratica è orientato come la stragrande maggioranza delle chiese e delle cattedrali cristiane. Si entra provenendo da dove tramonta il sole, dalle tenebre, e ci si avvia nella direzione in cui sorge, verso la Luce.
MA PERCHÉ I TRACCIATI DEI LABIRINTI DI ALATRI E DI CHARTRES SONO UGUALI?
Esiste un altro esemplare di labirinto preciso a quello francese. A Lucca, murato sulla facciata della Cattedrale di San Martino.
C’è forse una relazione con il fatto che molti dei centri che ospitano esemplari di labirinti, si trovano lungo vie di pellegrinaggi o sono mete degli stessi? Come la stessa Lucca, ma pure Pontremoli (nella chiesa di San Pietro), Aulla (a San Caprasio ma scomparve durante la Seconda Guerra Mondiale) Piacenza (labirinto che, come spigatomi dal professor Francesco Camia, oggi non più esistente ed era stato realizzato nella chiesa di San Savino) e Pavia (a San Michele, ma rimane soltanto un frammento). E, appunto le grandi cattedrali gotiche francesi.; Chartres in testa.
Tutte dedicate alla “Nostra Signora”, le quali disegnano sulla superficie terrestre ciò che le stelle della Costellazione della Vergine tracciano in cielo.
Labirinto di Lucca

Labirinto di Pontremoli
Al momento si ha un’unica, incontestabile certezza. Al mondo, esistono attualmente tre labirinti, Alatri, Chartres e Lucca, dal tracciato assolutamente uguale.
Ma qual’è il “modello originale”? Chi ha copiato chi? Oppure l’esemplare primigenio, l’archetipo è celato altrove?
A livello teorico, il labirinto di Alatri dovrebbe essere più antico di quello di Chartres, che la letteratura sull’argomento riconduce ai primi decenni del XIII secolo. L’Archetipo, l’Idea di un qualsiasi manufatto, normalmente precedono la realizzazione materiale dello stesso. Ebbene, un labirinto verticale non è stato fatto, ovviamente, per essere tangibilmente percorso. Rappresenterebbe, quindi, il concetto stesso di labirinto oppure il significato recondito ad esso attribuito. Ecco perché il labirinto alatrense, verticale, precederebbe concettualmente e temporalmente quello di Chartres; orizzontale e percorso realmente dai fedeli nel Medio Evo. Inoltre, un labirinto “unicursale” testimonia una ideologia, una filosofia di vita, una professione di Fede, basate sul totale e fiducioso abbandono ad una volontà superiore. Certi, non soltanto della sua infallibilità, ma pure della sua infinita bontà e misericordia nel prendersi cura delle proprie creature. Convinzioni salde come una roccia. Tipiche degli appartenenti agli Ordini Monastici Regolari e a quelli Ospitalieri e Cavallereschi. In particolare i Templari.

L’ipotesi “Templare” non è nuova. Fu una di quelle avanzate anche da Manchìa nel 2002. Il sottoscritto, durante le ricerche che poi sono confluite nel libro “Valcento”, ha trovato numerosi indizi della presenza dei Cavalieri dai Bianchi Mantelli ad Alatri.
Sulla controfacciata di ingresso della stessa chiesa di San Francesco, si può ammirare ancora oggi una “Croce patente” dipinta di colore rosso, simile a quelle adoperate dagli appartenenti al “Tempio”. Ed identica quelle tinteggiate nella chiesetta della Madonna del Carmelo a Fasana, località vicino a Pola in Istria. Attribuita proprio agli appartenenti al Tempio.
Sulla scalinata d’ingresso di San Francesco sono incisi tre esemplari del simbolo della “Triplice Cinta”, utilizzato anch’esso dai Templari. Infine, in quei paraggi, sorgeva un tempo un “Ospedale”.
Sopra un’altra controfacciata, quella della chiesa di San Silvestro (risalente al X secolo), sono state affrescate alcune croci dalla forma inconsueta ed interessante. La prima (per chi guarda da destra verso sinistra) spunta da sotto un intonaco più tardo (anch’esso ricoperto da dipinti databili al XIV secolo), si tratta di una “Croce trilobata (o “trifogliata”) rossa. La seconda è una piccola ”Croce patente” di colore scuro, appesa al collo di una figura femminile orante. Probabilmente la Vergine. L’ultima, forse la più intrigante, è una “Croce patente”, sempre di colore rosso, dipinta sopra la barba di un volto virile aureolato. E’ evidente che la croce è stata pennellata in un momento successivo, tanto che, quasi fossero in filigrana, sotto il colore rosso si vedono chiaramente i peli della barba del personaggio. Certamente un Santo, ma quale? Forse San Bernardo di Chiaravalle, “sponsor”, si direbbe oggi, dei Templari. Autore dell’opera “De Laudae Novae Militiae”, con la quale illustra, giustifica e loda la nascita della “nuova” cavalleria, tentativo di coniugare la figura e gli ideali del monaco con quelli del cavaliere. Oppure San Giovanni Battista, Patrono dell’Ordine? La croce potrebbe essere una sorta di “firma”?
Nemmeno le altre decorazioni del cunicolo ci vengono in aiuto. Si riconoscono, oltre a campiture floreali, anche colorate spirali, triplici circonferenze una dentro l’altra, stelle, sfere (forse le “sfere celesti”?) e “Fiori della Vita”.
Tutti simboli che hanno accompagnato l’Umanità durante il suo cammino, sin dalla Notte dei Tempi. In particolare il cosiddetto “Fiore della Vita”.
Graficamente è il risultato della composizione di sei cerchi intersecati tra loro, con un settimo posizionato centralmente. Una figura che, richiamandosi alla circonferenza, come appunto la ruota, la spirale e lo stesso disco solare, veniva vista come raffigurazione della Perfezione Divina. Il “Fiore” come il Sole, apportatore di vita. Ma anche della “Nuova” Vita, quella Eterna. Ecco perchè è pure simbolo ed auspicio di Resurrezione. Non per nulla lo si trova sia presso le grandi basiliche della Cristianità a Roma, come San Giovanni in Laterano, San Clemente, Santa Maria in Trastevere, oppure le abbazie cistercensi di Valvisciolo, Fossanova, Casamari nel Lazio, San Galgano in Toscana, Morimondo in Lombardia, o il mausoleo di Boemondo d’Altavilla a Canosa di Puglia (XII secolo), sia presso sepolcri o luoghi di culto pagani. Dal Tempio di Osiride ad Abido in Egitto, alla “Tomba del Guerriero” di Vetulonia, del VII secolo a.C.. Dove sopra una stele funeraria, oggi conservata a Firenze presso il Museo Topografico dell’Etruria, è stato scolpito un etrusco che regge una scure bipenne ed uno scudo decorato con un “Fiore della Vita”.
.jpg)
Cunicolo del labirinto – Fiore della Vita
Simbolo utilizzato anche dal “Tempio”. Come dimostrato dalla sua presenza sulla facciata della cosiddetta “Casa dei Templari” ad Anagni, alle spalle del Palazzo di Bonifacio VIII. Oppure sulla chiesa di San Bevignate presso Perugia, o ancora tra le decorazioni dei capitelli della chiesa di San Jacopo a San Giminiano ed infine sulla chiesa del Santo Sepolcro a Pisa. Tutti luoghi appartenuti all’Ordine del Tempio.
.jpg)
La Croce Patente di S Francesco
L’ipotesi che vede, quindi, i Templari come gli autori, o perlomeno committenti dell’affresco con il “Cristo nel Labirinto” ha trovato, in linea di massima, concordi anche due relatori del convegno del 24 aprile 2009. Il prof. Giuseppe Fort ed il dott. Adriano Forgione.
Riporto testualmente alcuni brevi stralci dei rispettivi interventi.
Fort ha analizzato non solo l’affresco con il “Cristo nel labirinto” ma tutto l’apparato pittorico ed iconografico e simbolico presente nel cunicolo (i “Fiori della Vita“, “spirali“, “Triplici circonferenze“, “sfere“, “stelle“). Indicandolo, senza alcuna ombra di dubbio, come medievale e cristiano. Stroncando così, definitivamente “tesi fantasiose che ancora circolano, come quella che lo attribuisce ad una fantomatica setta eretica giudaico-cristiana del I secolo d.C.. Ma al contempo ci parla di un cristianesimo esoterico, non nel senso che si attribuisce oggi alla parola, tipico dell’elite presente ai vertici dell’Ordine dei Cavalieri Templari”.
Sostanzialmente daccordo anche Adriano Forgione.
“La scoperta di Pavat è indubbiamente importantissima. Ma dobbiamo anche ringraziarlo per essere riuscito a richiamare la giusta attenzione nazionale sul Labirinto ed il Cristo che è all’interno“.
“La mia è un’ipotesi basata sul fatto che le decorazioni a corredo del labirinto, come i fiori a sei petali (chiamati appunto “Margherita Templare” o “Fiore della Vita“) e i “Tripli cerchi”, sono decorazioni tipiche impiegate dai Templari nelle loro costruzioni. In Italia e in Francia ce ne sono ancora moltissimi esempi. Inoltre, nell’ambiente del Labirinto di Alatri, le decorazioni sono particolarmente curate, precise, geometricamente perfette (per quanto riguarda labirinto e margherite templari) segno di un edificio importante e di una vera e propria scuola di decoratori all’opera e questo richiedeva anche molto denaro. I Templari questo denaro lo avevano. Inoltre va detto che queste decorazioni sono tipiche degli ossari cristiani di Gerusalemme del I secolo. Potrebbero essere stati proprio i Templari a volere tali decorazioni, in quanto portarono con loro da Gerusalemme, tra le altre cose, anche questo bagaglio culturale. Circa il significato della correlazione con Chartres, è necessario approfondire gli studi, ma è possibile che la committenza di entrambe le opere fosse appartenente ad un medesimo Ordine oppure che gli architetti che progettarono le due opere impiegassero le medesime conoscenze. Devo sottolineare che sebbene le cattedrali gotiche come Chartres non furono erette dai Templari, di certo la loro costruzione fu finanziata da quest’Ordine, e dunque le decorazioni interne (statue, mosaici, pavimenti ed affreschi) potrebbero essere state richieste proprio dai Templari; nello specifico il Labirinto e molti segnacoli di una conoscenza che all’epoca in Europa non esisteva. E’ ancora troppo presto per avere risposte certe. Quella dei Templari è certamente al momento soltanto una ipotesi, ma suffragata da buoni indizi“.
Il convegno è stato, dunque, non un punto d’arrivo ma di partenza. Ancora molte sfide, molti misteri da risolvere, attendono i ricercatori, archeologi, storici dell’arte, restauratori. I quesiti ai quali si accennava all’inizio, non hanno ancora trovato risposta.
Ma l’affresco è sempre lì. Attende in silenzio. Ma d’ora in poi, osservandolo, avremo almeno una sicurezza in più. Siamo davvero di fronte a qualcosa di straordinariamente unico. Che potrebbe celare le risposte a molti enigmi della storia e della spiritualità.
IL PROGRAMMA DI RAI DUE “VOYAGER” DI ROBERTO GIACOBBO SULLE TRACCE DEI MISTERI DI ALATRI

Ma il simbolo (“Triplice cinta” o “Cronografo solare”, come lo chiama Tofani) ha suscitato l’interesse anche degli autori del noto programma di Rai Due “Voyager” di Roberto Giacobbo.
Non per nulla, una volta giunti ad Alatri, durante la prima settimana di ottobre 2009, per filmare una puntata della trasmissione (puntata che andrà in onda probabilmente a febbraio del 2010) dedicata ai misteri della città megalitica, hanno intervistato anche Ornello Tofani, filmando pure il misterioso simbolo inciso sulle Mura Ciclopiche.
.jpg)
Roberto Giacobbo e Giancarlo Pavat
nel chiostro di S Francesco
Dopo alcuni sopralluoghi, svolti nei giorni precedenti, dagli autori di “Voyager” e dal regista della puntata alatrense Klaus Mayenza, giovedì 08 ottobre 2009, è arrivata ad Alatri la troupe del programma di Rai Due; il direttore della fotografia Massimo Gabrielli, con tutti i tecnici e gli specialisti, gli autori dottor Davide Fiorani, la dottoressa Valeria Botta e la dottoressa Francesca Conti, ed ovviamente il protagonista ed ideatore di “Voyager” Roberto Giacobbo.
.jpg)
Il Cristo nel labirinto
A suscitate l’interesse della famosa trasmissione di rai due che si occupa di misteri insoluti, è stata la notizia della scoperta, lo scorso inverno, da parte del sottoscritto, che il labirinto con il Cristo al centro, affrescato in un cunicolo del Chiostro di S Francesco ad Alatri, è identico a quello che decora il pavimento della navata della cattedrale di Chartres in Francia. Chartres, la cattedrale del mistero per antonomasia.
Grazie all’interessamento di Tommaso Pellegrini e Adriano Forgione, ebbi modo di incontrare gli autori Fiorani e Botta, ed illustrare l’importanza e l’unicità dell’affresco alatrense e tutte le ipotesi e misteri che lo circondano.
Ma Alatri è pure la città dalle misteriose Mura Megalitiche, forse (io toglierei persino il “forse”) le meglio conservate di tutta l’Italia Centrale.
Costruzioni imponenti, soprattutto l’Acropoli, che sfidano il Tempo e la scienza degli Uomini. Turbando il sonno di archeologi, studiosi, ricercatori.
CHI LE HA COSTRUITE? QUANDO E PERCHÈ?
GUARDA CASO I MEDESIMI INTERROGATIVI CHE VENGONO FORMULATI PER L’AFFRESCO CON IL LABIRINTO.
Anche per questo motivo “Voyager” ha ritenuto opportuno recarsi ad Alatri e filmare le sue bellezze monumentali ed archeologiche, le sue opere d’arte e soprattutto i suoi enigmi.
Si è cominciato con il dottor Giorgio Copiz e l’ing. Giulio Magli del Politecnico di Milano. Presso lo spigolo nordest dell’Acropoli, dove si trova il leone in pietra (medievale o più antico? La discussione è ancor aperta) è stato intervistato e filmato Copiz, che ha spiegato la propria ipotesi, basata su elementi oggettivi, “di una pianificazione del territorio ciociaro, tramite l’erezione di fortificazioni in opera poligonale da antiche popolazioni, collegata ad allineamenti astronomici”. Studi che hanno trovato vasta eco sulla stampa specialistica, come sul numero dello scorso aprile della nota rivista mensile “Fenix”.
Altro protagonista della giornata (relatore anche del “IV Seminario Internazionale sulle Mura Poligonali” svoltosi ad Alatri proprio in quei giorni) il prof. Giulio Magli del Politecnico di Milano che da anni studia le acropoli megalitiche dal punto di vista dell’Archeastronomia, autore di numerose pubblicazioni, filmato nella cornice “stellare” dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino.
Tutte queste ricerche sembrano trovare conferma nella scoperta, a cui si è già accennato, di un simbolo della “Triplice Cinta” sul “Pizzo Pizzale” da parte di Ornello Tofani e Gianni Boezi, che sarebbe stato utilizzato come “cronografo solare”.
.jpg)
Voyager di notte sull Acropoli di Alatri
.jpg)
Tofani sull Acropoli vicino alla Triplice cinta
Lasciando la parola allo stesso Tofani (vedere l’apposito articolo) per descriverci la scoperta, che vedremo in onda su Rai Due, mi preme, in questa sede, dire soltanto che se l’ipotesi del “cronografo” venisse confermata (ed al momento tutto sembra andare in tale direzione) si avrebbe una retrodatazione dell’età dell’Acropoli e della stessa Alatri.
Andando a confermare gli studi e le teorie, inspiegabilmente snobbati dall’ “Archeologia Ufficiale” di Don Giuseppe Capone.
Che nonostante la veneranda età e qualche problema di salute, nella mattinata di domenica 11 ottobre, ha accettato di buon grado di sottoporsi ad una intervista filmata dalla troupe di “Voyager”.
.jpg)
Giancarlo Pavat con il regista Klaus Mayenza
Ho avuto il privilegio di assistervi, e posso garantire che è stata un’esperienza unica, commovente ed esaltante al tempo stesso, sentire con quale lucidità, sintesi espositiva, passione per lo studio ed amore per la propria Terra, Don Capone ha ripercorso le ricerche e le scoperte di una vita intera.
.jpg)
Pavat viene microfonato per essere intervistato nel chiostro di S Francesco
Tornando alla registrazione della puntata di “Voyager”, la posizione dell’ “Archeologia ufficiale” è stata illustrata dal dottor Luca Attenni, direttore del Civico Museo Archeologico di Alatri; il quale facendo il punto degli studi sulle “Mura Megalitiche”, ha dichiarato che potrebbero non essere state fatte dai Romani ma essere più antiche.
.jpg)
Voyager intervista il direttore del Museo Civico di Alatri Luca Attenni
Se il “megalitismo” di Alatri ha avuto, ovviamente, la parte del leone nei giorni di riprese del programma, non è stato decisamente da meno l’enigmatico affresco con il “Cristo nel Labirinto”, che da un anno sta facendo letteralmente impazzire tutti. Con convegni, articoli su quotidiani e stampa specializzata, dibattiti, accese polemiche, e l’Amministrazione Comunale alatrense, in primis il sindaco dottor Costantino Magliocca, ma pure gli assessori Giulio Rossi e Sandro Vinci, lodevolmente impegnati a valorizzarlo ed a salvaguardarlo.
.jpg)
Giacobbo con Ornello Tofani davanti al chiostro di S Francesco
Si è cominciato venerdì notte, quando sotto l’occhio vigile delle telecamere, ho attraversato la splendida piazza Santa Maria Maggiore, ulteriormente abbellita da luci sapientemente disposte e dai palazzi e chiese che si riflettevano sulla pavimentazione bagnata, spiegando il significato del simbolo della “Triplice Cinta” per i Templari, il loro legame con il Tempio di Salomone a Gerusalemme e l’ipotesi, avanzata da alcuni studiosi di simbolismo, secondo la quale l’archetipo della TC va ricercato nel simbolo del Labirinto.
.jpg)
Voyager intervista don Giuseppe Capone
Sabato sera, invece, ho rievocato il ritrovamento dell’affresco, nel tardo dicembre del 1996 da parte dei tre ricercatori alatrensi Ennio Orgiti, Orestino Fanfarillo e Paride Quadrozzi e la mia scoperta dello scorso inverno, ovvero l’identicità tra i labirinti della Città Ciclopica e quello di Chartres.
Inoltre ho esposto la convinzione dell’insediamento dei Cavalieri del “Valcento” anche ad Alatri. Come testimonierebbero, oltre ad una diffusa tradizione, alcuni elementi oggettivi. Ad esempio le “Croci patenti” affrescate nella Chiesa di S. Francesco ed in quella di S. Silvestro. Entrambe riprese da “Voyager”.
Ma la giornata di sabato è stata caratterizzata soprattutto dall’arrivo del conduttore ed ideatore del programma, Roberto Giacobbo. Che con la sua carica di simpatia, capacità di comunicazione e preparazione professionale, ha prima catturato l’attenzione del pubblico del “IV Seminario sulle Mura Poligonali” a Palazzo Conti Gentili e poi si è concesso un vero e proprio bagno di folla. Con appassionati di misteri, fans della trasmissione e semplici cittadini, giovani e giovanissimi, a chiedergli autografi, dediche sui suoi libri e le classiche foto-ricordo.
Dopo aver assaggiato le specialità locali in un noto ristorante di Alatri, nel tardo pomeriggio di sabato sono cominciate le riprese dentro e fuori il Chiostro di S Francesco. Momenti particolarmente più emozionanti si sono avuti quando Giacobbo è entrato nel cunicolo dove si trova il labirinto. Dopo alcune spiegazioni illustrate dal sottoscritto, è salito sopra una impalcatura, posizionata all’interno dagli operai comunali, in modo da trovarsi alla stessa altezza dell’affresco. Assieme alla storica dell’arte , pittrice, scultrice Laura Quatrini dell’Accademia delle belle Arti di Frosinone. La giovane ma preparata studiosa ha confermato la datazione medievale del dipinto, illustrandone alcuni aspetti. L’attribuzione Templare, pur non provata, allo stato attuale, da prove oggettive, è stata considerata la più probabile (come tra l’altro affermato anche dall’archeologo medievalista Giuseppe Fort e da Adriano Forgione durante il convegno del 24 aprile 2009).
Da piazza Regina Margherita (davanti al Chiostro), Roberto Giacobbo e la troupe si sono spostati prima sulle gradinate dell’adiacente chiesa di S Francesco e poi, nuovamente, sull’Acropoli, per filmare immagini indimenticabili in notturna del monumento.
.jpg)
Foto di gruppo con Roberto Giacobbo
Immagini che verranno viste in tutta Italia da milioni di telespettatori. Un occasione, forse irripetibile, per la città di Alatri e tutta la cittadinanza, per farsi conoscere ed ammirare. Un ritorno di immagine difficilmente quantificabile, uno “spot” pubblicitario che certamente concorrerà ad iscrivere di diritto la meravigliosa località Ernica nel novero delle “Città d’Arte” della Penisola.
Un successo al quale ha concorso l’Amministrazione Comunale, (da prendere ad esempio per quanto sta facendo per la storia, l’arte e la cultura della propria Comunità) con il proprio personale; dalla Polizia Municipale, ai tecnici, agli operai, di concerto con l’intera popolazione. Che ha sopportato alcuni piccoli disagi (alcune piazze, strade chiuse per alcune ore, con divieti di parcheggio ed interdizione al traffico veicolare) consapevole dell’importanza di quanto si stava verificando, ed ha mostrato calore e sincere simpatia per tutti i protagonisti di “Voyager”.
Grazie “Voyager”. Grazie Alatri!!.
Chiunque fosse interessato ad ulteriore materiale sull’affresco del “Cristo nel labirinto” di Alatri, compresa la pubblicazione edita dall’Amministrazione Comunale e distribuita gratuitamente al pubblico, durante il Convegno del 24 aprile, oppure a visitare il Chiostro di San Francesco, può contattare o il Comune di Alatri o la Biblioteca Comunale “Luigi Ceci”. biblioteca@comune.alatri.fr.it
MISSIONE COMPIUTA!
FINALMENTE TERMINATI I LAVORI DI RESTAURO AL “CRISTO NEL LABIRINTO”, RESTITUITO IN TUTTA LA SUA BELLEZZA E MISTERO AGLI ALATRENSI E A TUTTI GLI ITALIANI
Giornata di festa e pubblico delle grandi occasioni, sabato 21 aprile 2012 ad Alatri.
Nella gremitissima sala della Biblioteca Comunale “L. Ceci” di Alatri, è stata presentata la conclusione dei lavori di restauro dell’enigmatico ed ormai famosissimo affresco con il “Cristo nel labirinto”.
Presenti oltre al sindaco Giuseppe Morini, il consigliere con delega alla Cultura Carlo Fantini, il senatore della Repubblica Oreste Tofani, la dottoressa Graziella Frezza responsabile di zona della Soprintendenza ai beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici che ha curato il restauro, i restauratori Sergio Salvati ed Antonella Docci di Roma e molti dei ricercatori e studiosi, tra cui Tommaso Pellegrini, Ennio Orgiti, Gianfranco Manchìa, che nel corso degli anni si sono occupati del misterioso affresco.
.jpg)
da sinistra Il sindaco Morini, i restauratori dottoressa Docci
e dottor Salvati,
la soprintendente dottoressa Frezza,
il delegato alla cultura Fantini
ed il ricercatore Pavat
Durante i saluti ed i ringraziamenti di rito da parte degli amministratori comunali, il consigliere con delega alla Cultura Carlo Fantini, ha voluto ricordare l’impegno del suo predecessore come assessore alla cultura dottor Giulio Rossi. Ma non solo. Ha citato i nomi dei tre scopritori dell’affresco nel lontano 1996, Ennio Orgiti, Paride Quadrozzi ed Orestino Fanfarillo e, soprattutto ha avuto parole di ringraziamento per lo scrittore e ricercatore Giancarlo Pavat, presente in sala, che dal 2006 si sta occupando del “Cristo nel labirinto” e sul quale ha fatto numerose scoperte, tra cui il fatto che il labirinto è uguale a quello di Chartres (oltre che a quello di altri cinque labirinti, compreso quello di Grinstad in Svezia). Scoperta che ha dato il via all’interesse nazionale ed internazionale per l’affresco alatrense e che ha contribuito, come ricordato dalla dottoressa Frezza a far ottenere il finanziamento di 1000.000 euro per il restauro e di, quindi, il salvataggio dell’opera d’arte unica al mondo che versava in cattive condizioni e rischiava davvero per sparire per sempre.
foto gentilmente concesse dal Comune di Alatri e dalla Soprintendenza
ai Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per il Lazio
Il senatore Tofani ha invitato gli amministratori cittadini a sfruttare l’enorme potenzialità di turismo artistico e culturale che ha Alatri, unico settore di possibile sviluppo ed in grado di produrre benessere diffuso per tutti , in momenti di crisi economica quello attuale. Ma ha ricordato che opere ‘d’arte come quella del “Cristo nel labirinto” e successi come, appunto, quello del restauro dello stesso, non appartengono ad una sola Giunta Comunale, o partito o schieramento politico, ma a tutta la cittadinanza ed all’intero territorio.
Ha poi preso la parola la dottoressa Frezza, la quale ha per prima cosa ringraziato Giancarlo Pavat per quanto fatto per l’affresco, dandogli anche il merito della grande risonanza mediatica e dell’opera di divulgazione portata avanti nei confronti del “Cristo nel labirinto”. La Frezza ha illustrato le varie fasi del restauro, le procedure adottate e l’opera di sistemazione del cunicolo in cui si trova l’opera d’arte. Ha letteralmente catturato l’interesse del pubblico quando ha spiegato come, grazie ai lavori di restauro, sono stati chiariti alcuni degli enigmi che avvolgevano l’opera d’arte che studiosi da tutta Europa ammirano e desiderano visitare. I misteri risolti e quelli non ancor svelati (tra cui l’attribuzione dell’affresco) saranno oggetto di un articolo successivo.
foto gentilmente concesse dal Comune di Alatri
e dalla Soprintendenza
ai Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici per il Lazio
Altrettanto interessanti sono state le esposizioni del dottor Salvati e della dottoressa Docci che hanno spiegato come sono riusciti a salvare l’affresco ma soprattutto a scoprire altri particolari e decorazioni simboliche, in particolar modo nel terzo ambiente del cunicolo (ora il primo a cui si accede dal nuovo comodo ingresso) l’ambiente. Un mondo inaspettato si è aperto agli occhi dei restauratori e dora a quello di tutti coloro che si affacceranno al chiostro di San Francesco. Sotto centimetri e centimetri di sporcizia accumulatasi nel corso dei secoli attendevano pazientemente intere pareti ricoperte da freschi raffiguranti tralci vegetali, coloratissime circonferenze, altri “Fiori della Vita” ed altre simbologie.
Ecco perchè alla fine è stato impossibile trattenere ancora il numeroso pubblico che si è riversato entusiasta a piazza Regina Margherita ed al chiostro di San Francesco. Qui, dopo il tradizionale taglio del nastro effettuato dalla dottoressa Frezza, a piccoli gruppi si è potuto , finalmente, accedere al cunicolo per rimanere letteralmente a bocca aperta davanti al “Cristo nel labirinto” ed alle altre decorazioni restaurate.
.jpg)
Affresco con il Cristo nel Labirinto (prima del restauro)
“Un lavoro fantastico”, è stato l’unanime commento dei presenti, qualcuno con le lacrime agli occhi. Una missione, un compito, quello di salvare l’affresco, iniziata nel 1996, proseguita tra mille difficoltà , polemiche, tentativi di far riscivolare tutto di nuovo nell’oblio, finalmente conclusa.
“Missione computa” ha commentato lo scrittore e ricercatore Giancarlo Pavat “giorni fa sono stato contattato personalmente dall’assessore Carlo Fantini che mi ha avvertito della fine dei lavori di restauro. Ringrazio il dottor Fantini e l’amministrazione alatrense per questa gentilezza e cortesia. E’ una enorme soddisfazione il fatto che i lavori siano terminati. Vedere ora l’affresco e rammentare com’era ridotto anni fa quando lo vidi per la prima volta è davvero commovente” prosegue Pavat “Il “Cristo nel labirinto”, questa opera d’arte iconograficamente unica al mondo, è salva!. Questo era uno degli scopi principali sin da quando, sei anni fa, su invito dell’assessore dell’epoca l’avvocato Costantini, comincia ad occuparmi con le mie ricerche dell’affresco. Dobbiamo essere orgogliosi come Italiani per questo restauro e per il salvataggio di un altra delle opere d’arte che rendono unico al Mondo il nostro Paese. Troppo spesso denigrato dai suoi stessi cittadini. Soprattutto in momento di crisi come questo, dobbiamo ricordarci che nessuno può darci lezioni di Civiltà e Cultura” sottolinea il ricercatore “Anche per questo motivo desidero ringraziare tutti coloro che hanno in qualche modo contribuito a questo successo.
.jpg)
Affresco del Cristo nel labirinto (prima del restauro)
In primis i precedenti amministratori comunali, il dottor Costantino Magliocca ed il dottor Giulio Rossi per aver creduto nella missione di salvare l’affresco. Senza scordare quelli attuali, per aver proseguito sulla stessa strada. Ma un ringraziamento va pure al dottor Antonio Agostini e soprattutto alla Soprintendenza ed alla dottoressa Graziella Frezza ed ai restauratori Salvati e Docci, per l’opera di restauro e salvaguardia. Impossibile senza il finanziamento che sono riusciti ad ottenere. Finanziamento che, per stessa ammissione degli Enti preposti, sarebbe stato difficile, se non impossibile ottenere, senza la grande esposizione mediatica che si è riusciti realizzare per il Cristo nel labirinto. E a tale proposito” conclude Pavat “parole di gratitudine vanno a coloro che mi hanno dato concretamente una mano per far conoscere al grande pubblico questo tesoro artistico alatrense. Ovvero gli amici Tommaso Pellegrini ed Adriano Forgione. Quest’ultimo, con il suo staff e la sua rivista Fenix è stato il primo a credere nel valore dell’affresco e nell’importanza delle ricerche che stavo portando avanti, dandone ampio spazio in diverse occasioni (non ultima nel numero di aprile in questi giorni nelle edicole NDR). Per non parlare del sito “Luoghi misteriosi” che sin dall’inizio ha ritenuto importantissimo seguire le ricerche sull’affresco. Infine come non ricordare il programma di Rai2 “Voyager” di Roberto Giacobbo, Un grazie ai suoi autori Davide Fiorani e Valeria Botta e a tutto lo staff”.
.jpg)
Pavat nel cunicolo del labirinto
Quella di ieri è stata, quindi, una giornata di cui andare fieri. Un lavoro, quello della Soprintendenza, dei restauratori, dell’attuale Amministrazione Comunale e di quella precedente, e di tutti coloro (compresi noi di “Luoghi Misteriosi”) che, in qualunque modo hanno contribuito negli anni a far sì che un simile giorno potesse finalmente spuntare, di cui essere orgogliosi.
L’affresco con il “Cristo nel labirinto”, aldilà dei misteri risolti e quelli ancora da esplorare (di entrambi torneremo a breve ad occuparci), è stato restituito alla Città di Alatri.
Ma di fatto l’opera d’arte appartiene a tutti gli Italiani e non solo perchè la proprietà è dello Stato e perché sono stati utilizzati soldi pubblici.
Ma perché, proprio per la particolare attenzione ed interesse internazionale per l’affresco, il successo nell’opera di restauro sta lì a dimostrare che gli Italiani sono un Popolo che sa tutelare, proteggere, far risorgere il proprio Passato, la propria Storia, la propria Arte e Cultura che nessuna Nazione al Mondo,proprio nessuna, può minimamente vantare.
RASSEGNA STAMPA

.jpg)
Voyager riscopre Alatri – Paginone
Ciociaria Oggi – 17-10-09
.jpg)
Le telecamere di Voyager a caccia dei misteri archeologici di Alatri
Ciociaria Oggi 06-10-09
.jpg)
La troupe di Voyager inizia le riprese televisive
Ciociaria Oggi 08-10-09
.jpg)
Voyager prime riprese sull’Acropoli
Ciociaria Oggi 10-10-09
Notte in città con le telecamere di Voyager
Ciociaria Oggi 12-10-09
.jpg)
Quatrini tra i protagonisti di Voyager
Ciociaria Oggi 15-10-09
.jpg)
Tutti pazzi per il labirinto – Ciociaria Oggi 16-03-09
.jpg)
Affreschi del chiostro urge un recupero concreto – Ciociaria Oggi 18-03-09
.jpg)
Fenix aprile 2009
.jpg)
Sopralluogo del direttore della rivista Fenix – 03-04-09
.jpg)
Cristo nel labirinto doppia sfida culturale – 21-04-09
.jpg)
Appuntamento questa mattina con il convegno 24-04-09.jpg)
Il Cristo nel Labirinto ha un gemello in Francia 25-04-09
.jpg)
Cristo nel labirinto valida la matrice templare – 05-05-09.jpg)
Cristo nel labirinto in una lezione alle Scuole Medie – Ciociaria Oggi 15-05-09
Rassegna stampa Ciociaria Oggi – 11-3-09
.jpg)
Intervista di Claudio Imperatore – Ciociaria Oggi 27-03-09
Approfondimenti sull’argomento nel libro
.jpg)
Valcento
“NEL SEGNO DI VALCENTO. Viaggio nel Lazio meridionale
attraverso le simbologie Templari e degli Ordini monastico
-cavallereschi” di Giancarlo PAVAT, Edizioni Belvedere.Per approfondire l’argomento suggeriamo il libro di Giancarlo Pavat:.jpg)
per saperne di più


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)