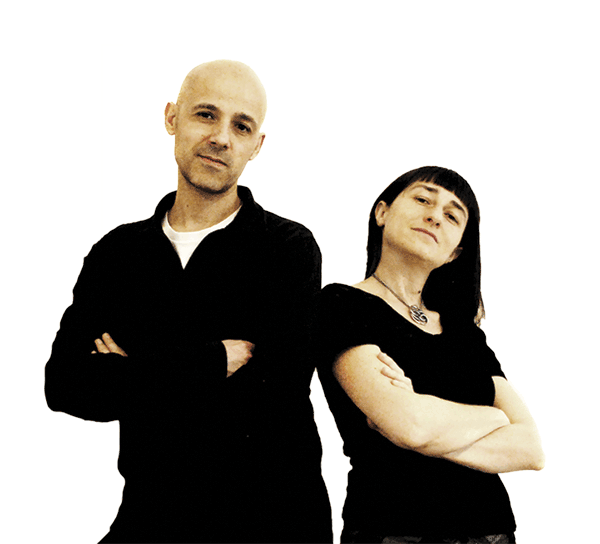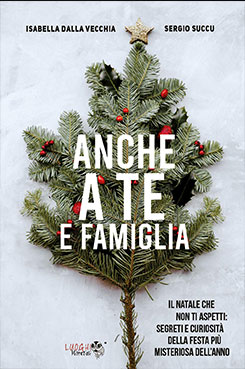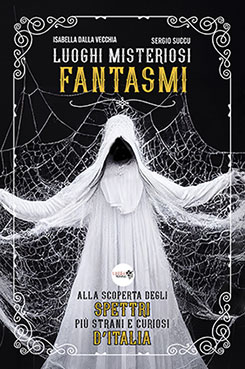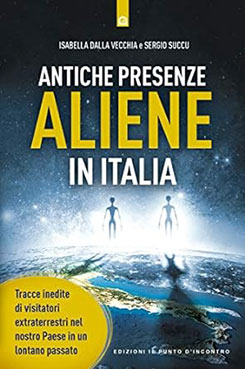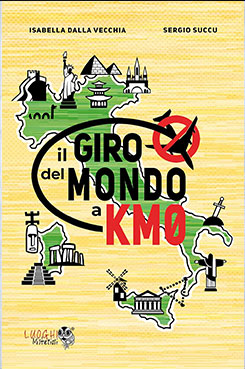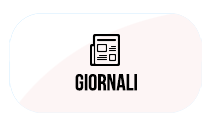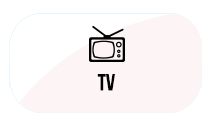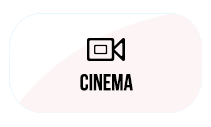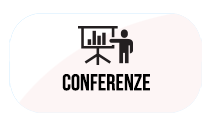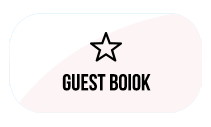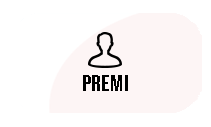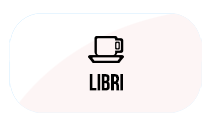![]() SESTO AL REGHENA (PN) – CHIESA DI SANTA MARIA IN SYLVIS / Questo luogo fu appartenuto ai cavalieri templari di cui troviamo testimonianza nel porticato detto “la loggetta” a sinistra dell’ingresso. Qui vi sono alcuni affreschi con tematiche di scene cavalleresche. Sul portale invece sono presenti San Michele e San Benedetto con il drago.
SESTO AL REGHENA (PN) – CHIESA DI SANTA MARIA IN SYLVIS / Questo luogo fu appartenuto ai cavalieri templari di cui troviamo testimonianza nel porticato detto “la loggetta” a sinistra dell’ingresso. Qui vi sono alcuni affreschi con tematiche di scene cavalleresche. Sul portale invece sono presenti San Michele e San Benedetto con il drago.
I CAVALIERI TEMPLARI, IL PARADISO DI FRONTE ALL’INFERNO E L’INSOLITO SGUARDO TRA UNA DONNA E GESU’

ARTICOLO E FOTOGRAFIE / Isabella Dalla Vecchia
__________________________
CATEGORIE
ALCHIMIA
ANGELI E DIAVOLI
BENE/MALE
CAVALIERI
ENIGMI SU GESU’
ENIGMI SULLA MADDALENA
GIUDIZI UNIVERSALI
INFERNO E PARADISO
OGGETTI MISTERIOSI
PERSONAGGI
TEMPLARI
Simbolo: ALBERO DELLA VITA

I capitoli di questa scheda sono:
• La sacra difesa dell’acqua
• Una chiesa particolarmente amata dai cavalieri templari
• I cavalieri della Loggetta
• Il templare Giovanni Michiel
• Il paradiso che “osserva”… l’inferno
• L’insolito sguardo tra una donna e Gesù
• Il cristianesimo longobardo
• L’urna di S.Anastasia
Video di Santa Maria in Sylvis realizzato dallo staff di Luoghi Misteriosi
La chiesa di Santa Maria in Sylvis, così chiamata perché anticamente si trovava in un fitto bosco (selva), è uno dei centri benedettini più importanti del Friuli.
Fu costruita nel VIII secolo dai fratelli Erfo, Anto e Marco, membri di una nobile famiglia longobarda, molto legata ai regnanti di Cividale e successivamente distrutta dall’invasione degli Ungari, ma venne ricostruita verso la fine del X secolo. Sono stati effettuati alcuni scavi intorno all’abbazia che hanno rinvenuto un edificio precedente ed alcune tombe.
La sacra difesa dell’acqua
E’ un’abbazia “fortificata”, presenta infatti un fossato che la circonda completamente e mura alternate da sette torri delle quali oggi rimane solo quella di accesso.
Il ruscelletto che la circonda, oltre a difenderla dagli attacchi, ha un chiaro richiamo simbolico alla “difesa spirituale”.
Infatti l’acqua purifica da qualunque male, essa circonda e rende vivo questo splendido luogo sacro. Indimenticabile per la pace che sa emanare, sia nel cortile d’ingresso, che nel giardino sul retro. L’energia di cui la chiesa è impregnata, è unica ed è impossibile non percepirla.
Una chiesa particolarmente amata dai cavalieri templari

Non a caso questo luogo fu appartenuto ai cavalieri templari di cui troviamo testimonianza nel porticato detto “la loggetta” a sinistra dell’ingresso. Qui vi sono alcuni affreschi con tematiche di scene cavalleresche. Sul portale invece sono presenti San Michele e San Benedetto con il drago.
Ai benedettini vennero affidate anche altre abbazie di stampo templare, tra cui l’abbazia di Rosazzo e Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli, questo perchè fra i benedettini e i templari vi era una certa amicizia e fratellanza. L’abate di Santa Maria in Sylvis, Goffredo, fu tra l’altro nominato patriarca d’Aquileia (altra magione templare). I monaci benedettini vissero in simbiosi con i patriarchi d’Aquileia e gli uni o gli altri erano anche cavalieri appartenenti all’Ordine. Non per nulla i patriarchi venivano chiamati “Vescovi con la spada”.
Un altro fatto anomalo è che la costruzione di Santa Maria vantò di essere supportata da molte donazioni tra le quali spiccano le generose offerte di Carlo Magno e del patriarca di Aquileia, Berengario.
I soldi, si sa, non arrivano mai senza un motivo, ma a sostegno di cause considerate di estrema importanza. Purtroppo nell’899 la chiesa venne distrutta dall’invasione degli Ungari, ma fu subito ricostruita, ristrutturata ed ampliata. Sempre grazie alle donazioni… Anzi, divenne ancora più ricca, ottenendo uno splendore come pochi e poteva avvalersi di innumerevoli possedimenti in Veneto, Friuli e Istria.
Essa è stata tra i baluardi dei possedimenti templari che cominciavano a diventare ricchi e potenti, uno dei motivi per cui Roma li soppresse tanto violentemente.
Fu recuperata solo nei primi anni del ‘900.
I cavalieri della Loggetta

Qui vi sono rappresentati alcuni temi profani con affreschi del XIII secolo, sulla parete est un duello tra cavalieri e sul lato sud Carlo Magno tra i suoi cavalieri, nella cui parte superiore vi sono le scritte “OTINEL – BELISSANT” che identificano i personaggi rappresentati, protagonisti della “Chanson de Roland”.
Il templare Giovanni Michiel
Sopra il portale è collocato un affresco staccato dalla loggetta con lo stemma dell’abate commendatario Giovanni Michiel (1464 – 1503) con in testa il cappello cardinalizio.
Egli finì il lavoro di rinnovo dell’atrio e del vestibolo dell’abbazia. Giovanni Michiel di origine veneziana, fu scrivano estensore della Regola e affiliato all’Ordine Templare. Egli fece eseguire anche l’affresco di S.Benedetto in cattedra.
Il paradiso che “osserva”… l’inferno

La chiesa è in stile romanico ed è possibile raggiungerla solo dopo aver percorso un lungo atrio sorretto da due file di quattro pilastri. Entrando si viene totalmente coinvolti da due scenari di spettacolare suggestione… l’inferno a sinistra e il Paradiso a destra. La scena infernale è particolarmente spaventosa perché descritta nei minimi dettagli, le anime dannate subiscono ogni tipo di sadica tortura per le quali è impossibile non essere turbati. Ma la cosa più agghiacciante è che a destra, nel Paradiso, vi sono tutte le anime beate che composte, osservano senza emozioni il terrificante scenario che hanno di fronte. Certo la scena principale è l’incoronazione di Maria, ma pochi sono rivolti all’evento, la maggior parte dei presenti guarda verso di noi.
Passandoci in mezzo, ci sentiamo inevitabilmente osservati, semplici uomini che camminiamo sulla Terra, attraversiamo questo “corridoio” di transizione, qui, in attesa di entrare a far parte anche noi dell’una o dell’altra parete…
L’insolito sguardo tra una donna e Gesù

All’interno vi sono esposti alcuni affreschi staccati del XV in cui campeggiano diverse figure femminili incoronate a cui non è stato attribuito un significato particolare. Una donna è in ginocchio, mentre l’altra ha le braccia incrociate sul petto e contempla il volto di Gesù visibile dentro un nimbo. Essendo prive di aureola non è possibile attribuirle a sante o martiri. Quest’ultima suscita però diversi interrogativi, che non possiamo ignorare. Esso non è un affresco “qualunque”.
Se osservato con attenzione si scorge una profonda intesa tra Gesù e la donna incoronata, una complicità quasi… romantica. Questa donna contempla sì Gesù, ma porta in sè un sospiro d’amore, dettato dal sorriso tipico dell’innamoramento. Allo stesso tempo Gesù non le appare trionfante tra luci e angeli, è solo. Sbircia dall’angolo del cielo, quasi… di nascosto. Quanto basta per osservare la fanciulla e al contempo in modo discreto, quasi per non essere visto. E i loro sguardi sono complici, come se “parlassero” senza che nessuno di noi li possa ascoltare.
Vi è un altro affresco del XV secolo staccato dopo la Seconda Guerra Mondiale raffigurante S.Cristoforo e la Madonna col Bambino tra i Santi Giovanni Battista e Giacomo Maggiore
Vi sono esposti anche alcuni reperti medievali.
Il cristianesimo longobardo
Sono stati anche ritrovati alcuni interessantissimi reperti in stile longobardo che testimonia quanto l’abbazia fosse legata alla corte di Cividale. Abbiamo gli “occhi di dado”, perle forate, astragalo a bambù, margini cordonati e corone a spina di pesce; tutti classici decori longobardi.

L’urna di S.Anastasia
Si trova al centro della cripta ed tra i tesori più preziosi del Friuli. Essa è stata realizzata nel VIII secolo con tecnica esecutiva di alto pregio, dato uno splendido e accurato decoro che la ricopre. Probabilmente veniva sistemata verticalmente dato che solo tre lati sono decorati.
Il materiale è marmo bianco purissimo. La copertura che doveva aessere ben visibile, è divisa in tre parti, al centro spicca una croce fiorita con vegetali e trifogli a spirale, dentro un cerchio decorato a spina di pesce, metafora della corona di trionfo, iconografia diffusa. Sopra e sotto vi sono due coppie di archetti lavorati a tortiglione che rappresentano l’albero della vita. Ai lati viene ripatuta la croce fiorita con rosette, margherite, gigli e di nuovo l’albero della vita.
L’urna compare per la prima volta nel 1339 descritta in una pergamena tutt’oggi conservata nella biblioteca di Udine. Entrando nella cripta buia spicca con quel bianco etereo, bellissima, lo sguardo si perde nelle spirali di quelle decorazioni magiche, che solo un Cristianesimo antico, longobardo e quindi un po’ “pagano” sapeva creare.
Gli altri affreschi della chiesa:
Il sito dei luoghi misteriosi
www.luoghimisteriosi.it – info@luoghimisteriosi.it