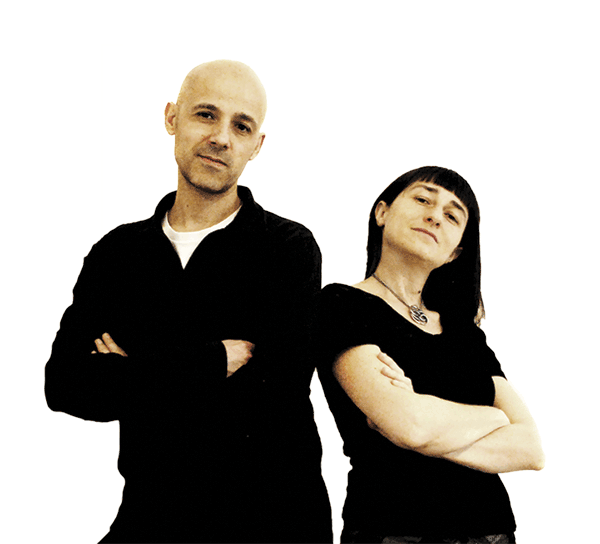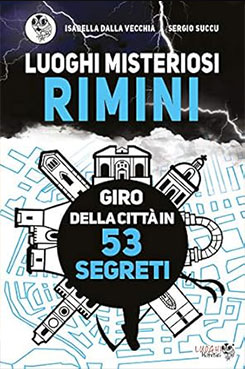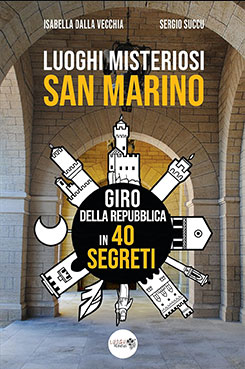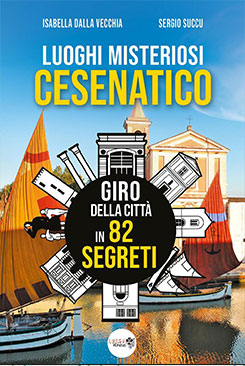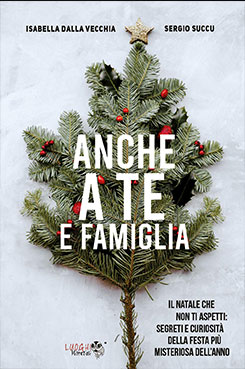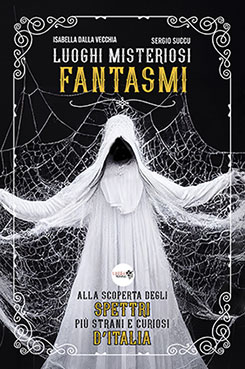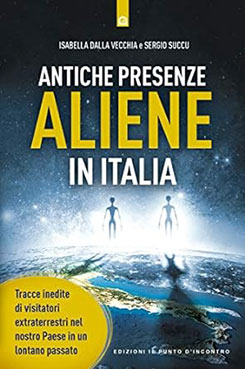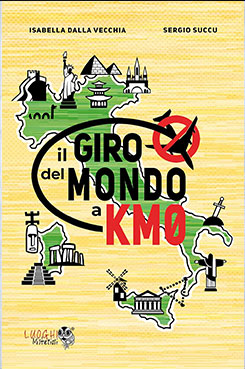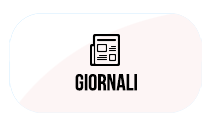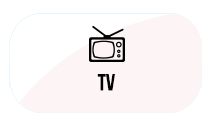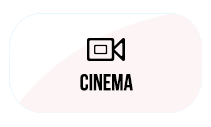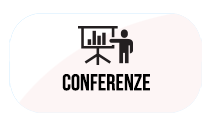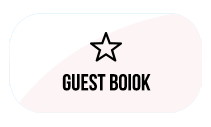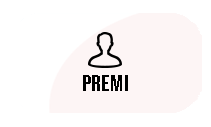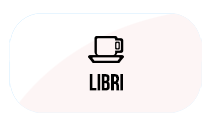![]() SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – GLI IPOGEI /Queste gallerie sotterranee pare siano state frequentate dai monaci basiliani, ma ancora prima si dice siano stati antichi Mitrei, templi dedicati al dio Mitra…
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – GLI IPOGEI /Queste gallerie sotterranee pare siano state frequentate dai monaci basiliani, ma ancora prima si dice siano stati antichi Mitrei, templi dedicati al dio Mitra…
I MISTERIOSI IPOGEI

ARTICOLO E FOTOGRAFIE / Isabella Dalla Vecchia
__________________________
COSTRUZIONI ANOMALE
FEMMININO SACRO
INSPIEGABILE
PAGANESIMO/CRISTIANESIMO
PERCORSI INIZIATICI
PREISTORIA
RITUALI
TECNOLOGIE DEL PASSATO

I capitoli di questa scheda sono:
• Le misteriose gallerie e il Colle Giove
• A cosa servivano?
• Semplici cantine o luoghi di antichi culti?
• Il culto della Dea Madre
• La presunta datazione
• Felici, Contradina e Monache, gli esempi più enigmatici
• La sala circolare della Grotta Contradina
• Un mistero irrisolto
|
QUESTO ARTICOLO E’ TRATTATO IN MANIERA APPROFONDITA DA LUOGHI MISTERIOSI SULLA RIVISTA HERA N°129 DI OTTOBRE 2010 |
|
 |
|
Le misteriose gallerie e il Colle Giove

Santarcangelo di Romagna, tranquilla cittadina ubicata sul Colle Giove, nasconde una seconda città sotterranea costituita da un labirinto di corridoi, stanze e nicchie, la cui origine è tutt’oggi misteriosa.
Perché, quando e da chi è stata creata?
All’interno del Colle si diramano 153 ipogei artificiali ricavati nell’arenaria e nell’argilla, distribuiti su 3 livelli collegati tra loro tramite pozzi, aperture e scale, ai quali si accede dalle stesse case private e non dall’esterno (tranne in qualche raro caso), impedendo così l’entrata a qualsiasi passante.
Tramite le scale si passa da un livello inferiore ad un atro superiore
Il Colle Giove presenta, fin dalla preistoria, una struttura “a gradoni” in prossimità delle cui zone pianeggianti sarebbero situate le entrate delle grotte.
.jpg)
Schema del Colle Giove
Tratto da “Atti della giornata di studi Santarcangelo”
Sono state censite due tipologie differenti , la prima consiste in corridoi di 1,20 metri di larghezza e 2 metri di altezza, con nicchie laterali a “pettine” distribuite in sequenze regolari; la seconda comprende stanze a pianta rettangolare o circolare con colonne e coperture a cupola o a volta.
.jpg)
Tratto da “Atti della giornata di studi Santarcangelo”
.jpg)
.jpg)
Tratto da “Atti della giornata di studi Santarcangelo”
A cosa servivano?

Le ipotesi sul loro utilizzo sono innumerevoli e spaziano dall’uso a deposito, fino alla frequentazione rituale dei monaci Basiliani o da popolazioni pagane devote al Dio Mitra che richiedeva la frequentazione di templi sotterranei.
Il più importante studioso che ha attivamente lavorato nell’obiettivo di scoprire ed identificare una loro origine è Luigi Renato Pedretti, che ha portato avanti il più completo lavoro di ricerca e studio, basato su ipotesi ma anche su documenti minuziosamente raccolti e catalogati.
La prima ipotesi è quella per la quale sono tutt’oggi utilizzate, ossia il loro impiego a cantina per la conservazione di vini ed alimenti. Esistono però diverse prove, sempre secondo Pedretti, che lo escluderebbero, troppo complesse e perfette perché siano state create solo come magazzini.
Semplici cantine o luoghi di antichi culti?

Ogni abitazione ne possiede una, ogni ipogeo fa parte della quotidianità degli abitanti del paese ed è usuale vederle rientrare in una vendita catastale.
Ma esse hanno un’origine ben più antica e per diversi motivi la loro funzione non può limitarsi a quello di semplice “cantina”. Il fatto di essere così complesse nella loro forma strutturale, con nicchie scavate in modo regolare ed identico, con stanze circolari perfette, con la presenza di colonne non per forza “portanti” e di pozzi che garantivano un ricambio d’aria adeguato per una certa abitabilità, ci obbliga ad interrogarci ulteriormente sulla loro autentica funzione. Sicuramente questa perfezione esecutiva porta alla teoria sul loro utilizzo a luogo di culto.
In una nicchia del corridoio principale è presente un pozzo aperto alla sommità che garantisce il ricambio d’aria, collegando l’ambiente con una grotta superiore di diversa appartenenza.
Troppa precisione, troppo impegno ingegneristico che ha portato il Pedretti, ad attribuirgli un ipotetico utilizzo come basiliche da parte dei Monaci Basiliani, votati al monachesimo orientale.
E’ accaduto spesse volte in Italia, che diversi monaci eremiti si siano ricoverati in totale clausura e solitudine in grotte naturali o ipogei. Abbiamo diversi esempi in Sardegna con la figura dei monaci Nicola e Trano vissuti per anni in grotte a tofani nella Gallura, il cui esempio è stato poi seguito da altri eremiti.
esempio di Domus de janas in Sardegna
I primi cristiani erano comunque soliti ad “occupare” le grotte e non certo a costruirle di loro punto. Il loro scopo non era l’edificazione ma la preghiera in luoghi magari “indicati da Dio”, motivazione che fa supporre al fatto che gli ipogei, da loro abitati, erano già presenti prima della loro eventuale frequentazione.
Questo riporta ad un’altra valutazione, ossia che le gallerie fossero state utilizzate come mitrei, templi dedicati al Dio Mitra, che si trovavano sempre in ambienti sotterranei o comunque all’interno di grotte.
Queste lunghe gallerie potevano essere ambienti per percorsi iniziatici e per rituali antichi a noi sconosciuti, anche perché segreti già allora e spesso di difficile comprensione anche agli stessi apprendisti. E’ stato supposto anche l’utilizzo per culti segreti massonici, per via soprattutto delle nicchie spesso in numero dispari (perché contrapposte simmetricamente in numero pari, ma con la presenza di un’ultima nicchia ad abside).
In Italia abbiamo moltissimi esempi di ipogei sotterranee utilizzati certamente come tombe, ma anche come luogo cultuale.
Il culto della Dea Madre

La grotta fin dall’antichità è da sempre stata vista come simbolo dell’utero materno, le stesse salme venivano riposte in posizione fetale in antri dipinti di rosso (il colore della placenta) affinchè la nostra Grande Madre li facesse rinascere a nuova vita. Le gallerie che conducono alla luce dell’uscita sono metafora del viaggio attraverso il collo dell’utero verso la vita durante l’evento divino del parto. Il colle Giove, con la sua forma rotonda potrebbe benissimo essere la pancia della Terra.
La luce, la via verso la nostra nuova vita è vista in questo caso a livello spirituale, poiché nel buio labirintico dell’ignoranza, persi in mille domande irrisolte nel vuoto delle nicchie, cerchiamo, muovendoci all’interno del labirinto, la via d’uscita, verso la luce della conoscenza.
Gli occhi si aprono al sole. Il labirinto, simbolo per eccellenza del percorso iniziatico su questa terra, che ritroviamo sui muri delle chiese o nei pavimenti e nei soffitti dei palazzi, o nei giardini dei castelli, in questo caso è fisicamente percorribile e tangibile. E il visitatore lo tocca con mani… e piedi.
Per un curioso gioco del destino conservare oggi qui il vino, anche se è un fatto puramente pratico, porta con sé una grossa carica simbolica. Il vino è il simbolo per eccellenza del sangue ed esser circondati dal prezioso liquido ci riporta alle nostre origini di neonati confusi in un utero buio, il cui unico punto di riferimento è la luce dell’uscita, quella autentica che può essere individuata solo nelle tenebre.
La presunta datazione

Le grotte di Santarcangelo non vengono mai citate in documenti precedenti al 1496, data riferibile ad un documento che le citerebbe in tal modo: “CUM DUABUS VOLTIS FABRICHATIS VIA COMUNIS”, dove la “volta” viene intesa come luogo sotterraneo. Esistono altri documenti nel 1516 e nel 1607, ma è solo dal 1701 in poi che vi è una vera e propria cascata di 134 documenti che le catalogano come depositi vinari. Luigi Pedretti era riuscito quasi a risalire ad una pergamena del 300 d.C. scritta in latino, greco ed egiziano in cui venivano citati gli ipogei di Sant’Arcangelo, ma risulta scomparsa dall’Istituto Pergamene di Roma. Anche l’archivio Vaticano nega di possedere alcun documento in cui vengono descritti gli ipogei. Tutti questi documenti anzichè trattare di una loro costruzione, riportano un valore di mercato, dunque erano già presenti nel passato?
Felici, Contradina e Monache, gli esempi più enigmatici

Le grotte più enigmatiche sono la Grotta Felici, la Grotta Contradina e soprattutto la misteriosa Grotta delle Monache di clausura con accesso dal Convento di SS. Caterina e Barbara. L’unico ipogeo visitabile però è la Grotta Contradina tramite l’ufficio IAT, Pro Loco Santarcangelo, che organizza visite guidate.
.jpg)
La Grotta Contradina
Tratto da “Atti della giornata di studi Santarcangelo”
Quest’ultima è costituita da un lungo corridoio con 26 nicchie che culminano in una sala circolare molto ampia con a sua volta 7 nicchie lungo tutta la parete, con cupola tufacea a sesto ribassata. La sala circolare, per la sua regolarità e perfezione, ha il misterioso aspetto di un tempio. Impossibile non essere avvolti da un senso di misticità e da enigmatiche domande: cosa avveniva qui dentro?
.jpg)
La Grotta Felici
Tratto da “Atti della giornata di studi Santarcangelo”
La particolarità della Grotta Felici è la presenza di una lunga camera rettangolare con piccole nicchie e due file di due pilastri, otto per lato, simile ad una sorta di navata basilicale con copertura a botte, mentre la Grotta delle Monache simile nella struttura ad un tempio, si trova nel punto più alto del centro abitato (già questa posizione potrebbe attribuirgli l’utilizzo ad ambiente di culto).
.jpg)
La Grotta delle Monache
Tratto da “Atti della giornata di studi Santarcangelo”
La sala circolare della Grotta Contradina

di seguito alcune foto della sala circolare della Grotta Contradina visitabile tramite il IAT
Un mistero irrisolto

Impossibile trovare una collocazione nel tempo se non quella che percepiamo percorrendo questi oscuri corridoi. Un’eredità dal passato che parla di un mondo parallelo, quello sotterraneo, un aldilà percorribile dal nostro corpo a preparazione di quello che attraverseremo con la nostra anima o di quello che abbiamo percorso prima di nascere. Coloro che le hanno costruite conoscevano l’uomo, colui che ancora per noi risulta un mistero. Ancora una volta i nostri antenati ci comprendevano meglio di quanto noi gente del futuro, conosciamo loro, misteriosi popoli del passato.


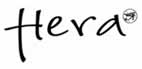 Luoghi Misteriosi sulla rivista HERA
Luoghi Misteriosi sulla rivista HERA