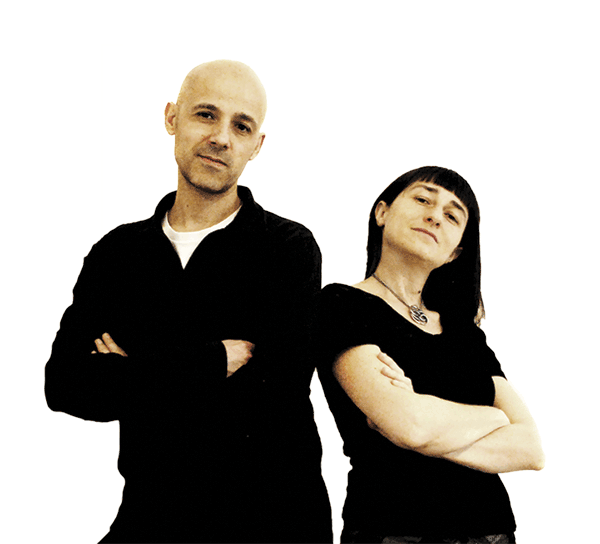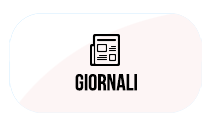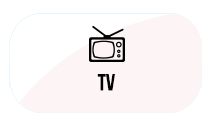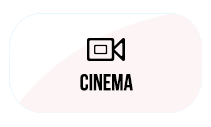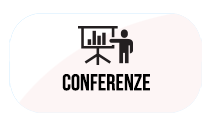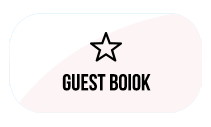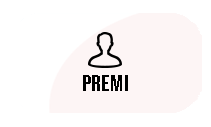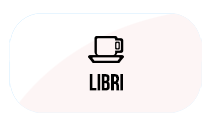![]() Castelcivita (SA) / L’idolo può rientrare tra quelli detti “a tavoletta” o “a pagnotta”, per la forma uguale alle tavolette enigmatiche o Brotlaibidole ritrovate a sud del Lago di Garda e nell’Europa centro-orientale e centro-meridionale, databili al 2100-1400 a. C.
Castelcivita (SA) / L’idolo può rientrare tra quelli detti “a tavoletta” o “a pagnotta”, per la forma uguale alle tavolette enigmatiche o Brotlaibidole ritrovate a sud del Lago di Garda e nell’Europa centro-orientale e centro-meridionale, databili al 2100-1400 a. C.
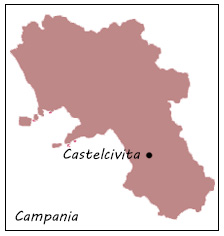
LE “BROTLAIBIDOLE” DI CASTELCIVITA

ARTICOLO E FOTOGRAFIE / Giuseppe Figliolia Forziati – giuseppefigliolia@tiscali.it
__________________________
CATEGORIE
![]() Coincidenze
Coincidenze
![]() Mura megalitiche
Mura megalitiche
![]() Pietre
Pietre
__________________________

A meno di un anno dalla pubblicazione del mio volume sull’intera vicenda storica del mio paese, “Castelcivita, la piccola Assisi degli Alburni”, il ritrovamento di straordinari manufatti ceramici mi fa retrodatare l’impianto urbanistico magnogreco del sito castelcivitese, l’antico oppido Alburno menzionato dallo scrittore latino Vibio Sequestre (IV sec. dopo Cristo). Studiando la pianta archeologica da me tracciata e considerando la specularità dell’impianto urbanistico, intravedevo, sopra all’acropoli o area sacra di S. Cono, corrispondente al rione alto-medievale longobardo La Terra, secondo l’originaria toponomastica, un altro recinto quadrangolare o temenos con tre torri angolari mancante della quarta torre per sopraggiunte modifiche medievali e per la costruzione, a oriente, della posterla gotica nel vicolo Arianna, sulla destra del n. civico 24: esso delimita e fornisce i confini toponomastici del rione altomedievale longobardo le Casaline, delimitato, ad occidente, dalla Rua di Crispino, oggi per buona parte corrispondente alla via Dedalo, secondo la toponomastica del 1920-22, che a sua volta lo separa dal rione Crispino, come ho avuto modo di apprendere da un atto notarile del mio archivio di famiglia e dallo stato delle anime della parrocchia di S. Cono.
.jpg)
Mura megalitiche micenee di Castelcivita (XV-XIV sec. a. C.)
Oggi, Castelcivita, la cui continuità abitativa ha dello stupefacente, fa da richiamo agli studiosi, grazie all’esatta contestualizzazione prodotta nel 2011 nello studio sull’oppido Alburno, al preciso tracciato dell’impianto urbanistico, lungo il quale sono ancora evidenti i resti murari megalitici, e consegna alla storia le prove concrete e le linee guida sulla presenza stabile dei minoico-micenei nella penisola italiana, ove costruirono vere e proprie colonie.
.jpg)
Tavoletta d’argilla inscritta in Lineare B (XV-XIV sec. a. C.)
Facendo una ricognizione, trovai una pietra in arenaria, levigata, con il vertice arrotondato e con l’altra estremità spezzata: la forma era interessante, perché richiamava alla mente la stele egizia o sumera e, perciò, decisi di portarla a casa; essa misura cm 8,4×6,5, spessore cm 3 ca.
.jpg)
Tavoletta d’argilla inscritta in Lineare A cretese (XVI-XV sec. a. C.)
Guardandola con tutta calma, anche perché l’avevo bagnata per pulirla, notai prima un triangolo centrale, scavato con una certa profondità, poi altre incisioni molto lievi, che cercai di definire giocando con la luce per creare chiaroscuri, palesandosi, così, rombi, triangoli, qualcuno con modanatura a lineette, ma senza riuscire a intravedere un disegno compiuto; il retro, non levigato, è caratterizzato da un motivo a rombi che occupa tutto lo spazio, terminante al vertice con un pennacchio; sullo spessore dell’arcuatura è presente una piccola traccia di pittura color carne. Pensando che fosse un altro reperto sumero, iniziai le ricerche dalla foto “Pandolfini”, perché tra i reperti vi era una piccola testa umana, stilizzata, a profilo triangolare, recante una modanatura geometrica fatta di triangoli riempiti da lineette, invece i risultati mi portarono a catalogare il reperto come idolo della civiltà cicladica, che precedette quella minoica dal 3200 al 2000 a. C.
Idolo a forma di tavoletta, pietra arenaria, civiltà cicladica, fronte e retro (2000 a. C. ca)
Gettando uno sguardo ad ampio raggio, l’idolo può rientrare tra quelli detti “a tavoletta” o “a pagnotta”, per la forma uguale alle tavolette enigmatiche o Brotlaibidole ritrovate a sud del Lago di Garda e nell’Europa centro-orientale e centro-meridionale, databili al 2100-1400 a. C. e per la modanatura a triangoli o a rombi che caratterizza, al vertice, l’arcuatura della pietra, ma si differenzia perché non presenta incisioni molto profonde e schemi e forme ben definite: “I documenti artistici delle Cicladi (…) sono i numerosi ed importanti idoli, statuette in pietra o marmo, databili per la maggior parte tra il 2500 e il 2000 a. C. (…) forse dee della fecondità e protettrici dei morti, come fa supporre il loro rinvenimento all’interno delle tombe, realizzate mediante la sovrapposizione di diverse forme geometriche […]” .
.jpg)
Ascia d’argilla, probabile labrys cretese (XVI-XV secolo a. C.)
L’idolo a forma di violino, conservato presso il Museo archeologico nazionale di Atene, datato al 2000 a. C. ca, è l’unico reperto che abbia incisioni molto simili all’esemplare castelcivitese : “Queste figure sottili, piatte, talvolta quasi come tavolette, si distinguono dagli esemplari cui abbiamo accennato, ed anche da quelli orientali, per una più severa stilizzazione (…) Nel corso dello svolgimento di questo tipo di figure, la stilizzazione aumenta a tal punto che non possono venir considerate una diretta rappresentazione della forma umana, ma piuttosto una ridotta e schematica interpretazione di essa” .
.jpg)
Bulla d’argilla, civiltà sumera (3300-3200 a. C.)
Tra gli esempi visualizzati durante la ricerca, però, non ho rinvenuto idoli cicladici che avessero la forma della tavoletta, perciò l’idolo di Castelcivita sembra suggerire che in esso siano confluite la civiltà sumera e quella cicladica, la stele sumera e le incisioni cicladiche, evidenziando quanto avanzato da alcuni studiosi sull’origine degli idoli cicladici da quelli mesopotamici: “I celebri idoli cicladici, seppur affini agli uscebti dell’antico Egitto sono di derivazione maggiormente mesopotamica e venivano utilizzati, per lo più ad usi funerari” .
La forma a tavoletta, la pietra arenaria e l’uso funerario rende il manufatto simile alle statue stele (o statue menhir) ritrovate in Italia, in particolar modo in Lunigiana e in Europa: “sono monumenti in pietra, generalmente di roccia arenaria, solitamente di tipo antropomorfo. Gran parte dei ritrovamenti di questi megaliti è avvenuta nelle zone dell’Europa centrale tra il Mediterraneo e le Alpi nelle odierne Francia e Italia. Ritrovamenti in Lunigiana. (…) Esse si collocano fra la tarda preistoria e l’arrivo dei romani, in un periodo storico che va presumibilmente dal III millennio a.C. al VI secolo a. C. (…) Le statue stele rappresentano uomini, (…) donne con i loro tratti estremamente stilizzati. Esistono ritrovamenti acefali. Il loro significato è destinato a rimanere oscuro. Forse rappresentavano dei e dee come la Dea Madre, o raffigurano eroi del tempo oppure venivano utilizzate come elementi di decoro funerario” .
.jpg)
Idolo a occhio, ceramica sumera (2600 a. C.)
Dai pochi dati a disposizione e dalle incerte datazioni fornite dall’archeologia, l’idolo di Castelcivita va datato al 2000 a. C., come l’idolo a forma di violino d’Atene, anno in cui decadde la civiltà cicladica, ricordando che le tavolette enigmatiche iniziano a datare dal 2100: esso può costituire, nei futuri studi, l’anello che congiunge gli idoli dell’Europa centrale e in particolare dell’Italia del Nord con quelli di produzione egea”.
<http://lamiapreistoria.blogspot.it/2011/01/statue-steli-della-lunigiana.html>
Per saperne di più
Per informazioni sull’acquisto del testo contattare l’autore
Giuseppe Figliolia Forziati – giuseppefigliolia@tiscali.it
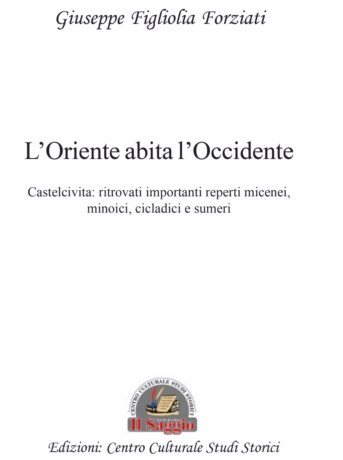
Il sito dei misteri
www.luoghimisteriosi.it – info@luoghimisteriosi.it


.jpg)
.jpg)