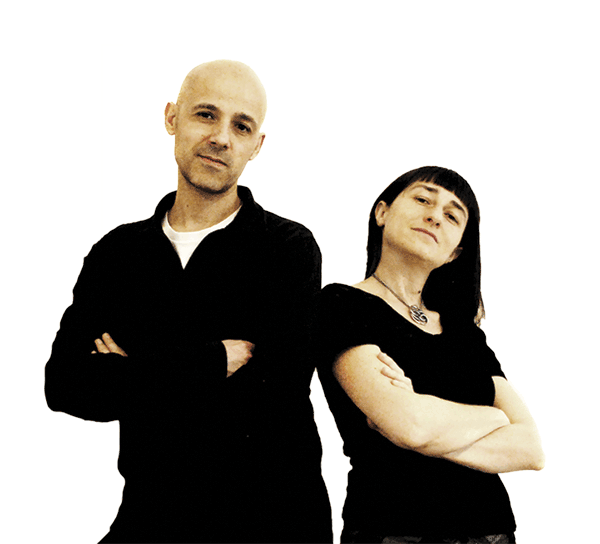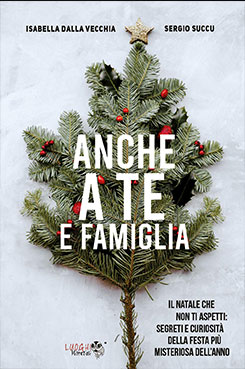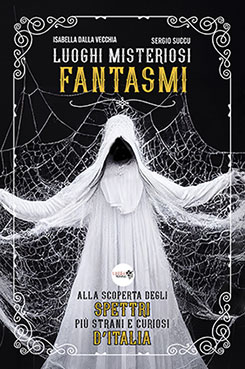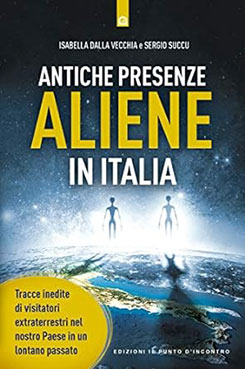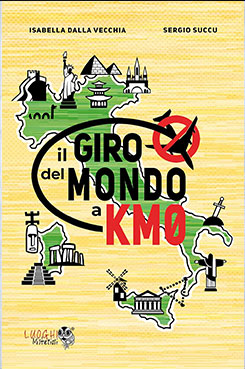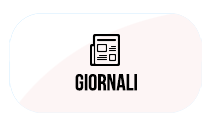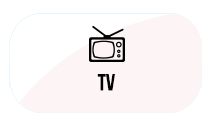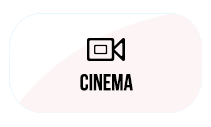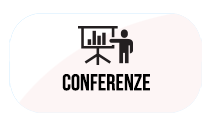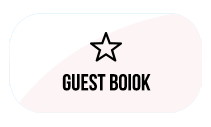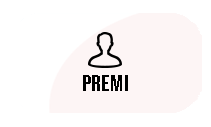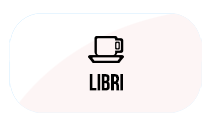![]() MONTELANICO (RM) – IL CASTELLO / All’interno di un pozzo granaio un bassorilievo fa pensare alla Dea Opi. Si pensava all’abbondanza, quindi a Cerere, quando il terreno era poco fertile; si pensava ad Opi quando la produzione era soddisfacente ed il solo problema era la conservazione.
MONTELANICO (RM) – IL CASTELLO / All’interno di un pozzo granaio un bassorilievo fa pensare alla Dea Opi. Si pensava all’abbondanza, quindi a Cerere, quando il terreno era poco fertile; si pensava ad Opi quando la produzione era soddisfacente ed il solo problema era la conservazione.
DEI O SANTI A PROTEZIONE DEL RACCOLTO
articolo e foto di Alessandro Ippoliti – a.ippoliti1942@libero.it
www.ippolitialessandro.it
__________________________
CATEGORIE
FEMMININO SACRO
![]() Italia sotterranea
Italia sotterranea
![]() Pozzi
Pozzi

All’interno di un pozzo granaio un bassorilievo fa pensare alla Dea Opi
A seguito di una personale ricerca sul castello di Montelanico (RM), sono sceso in una grotta sapendo di trovare qualcosa di interessante. Al termine della prima rampa di scale mi si aprì davanti un ambiente inconsueto. Iniziai a brandeggiare la torcia elettrica fin quanto non mi resi conto che questo ambiente era di forma campaniforme, alto circa 6 metri con pianta quadrata di 4 metri di lato, si trattava di un pozzo granaio, un silos sotterraneo probabilmente intercettato durante i lavori intrapresi per dotare la cantina parrocchiale della grotta di cui era sprovvista. Puntuale nella parete sud come mi era stato riferito vidi il basso rilievo: l’emozione fu grande, la veste lunga panneggiata, non lasciava dubbi, era una figura femminile romana. Notai anche che oltre al bassorilievo descrittomi ce ne era un altro, un ovale simile ad uno stemma araldico e un angelo stilizzato, mentre le pareti nord ed est presentavano una evidente prosecuzione della grotta in due bracci, per qualche motivo chiusi con una parete in muratura (sarebbe interessante conoscere cosa c’è dietro le due pareti).
Attestato l’ambito culturale romano non rimaneva che dare un significato a questa straordinaria presenza. Il significato doveva essere di natura cultuale, altrimenti perché relegare una espressione artistica all’interno di un pozzo lontano da apprezzamenti critici? La soluzione andava ricercata nella sfera dei timori e delle necessità che le genti di quel tempo avvertivano quotidianamente. La fortificazione dell’insediamento dava sicurezza per eventuali aggressioni e saccheggi, la protezione di una Dea doveva garantire il vivere quotidiano attraverso l’abbondanza e l’integrità del raccolto. Nell’alto medioevo, in modo particolare nelle piccole comunità, il culto dei santi serviva solo per rafforzare la fede dei credenti, niente o poco si sapeva dei specifici protettori: S. Antonio abate, protettore degli agricoltori; San Pancrazio, protettore del raccolto; San Magno, proteggeva il raccolto dagli insetti nocivi. Quindi meglio sarebbe stato affidare la loro protezione contro le carestie e la conservazione del prodotto ad una entità presente nella loro formazione culturale già dal III secolo a.C., la Dea Opi, protettrice del grano mietuto e riposto nei granai. Questa è la mia personale convinzione. La Dea Opi era una divinità romana, a Roma le furono dedicati due santuari di forma circolare, uno sul Campidoglio e l’altro nel Foro Romano e veniva celebrata due volte l’anno, il 25 di agosto e il 19 dicembre.
L’iconografia più accreditata presenta Opi seduta sul trono stringente nella mano destra tre spighe di grano. Ora se sovrapponiamo questa descrizione all’immagine che è giunta fino a noi, l’attribuzione non è azzardata. Ritengo inoltre che per la scelta del culto di Opi o di Cerere determinante fosse la fertilità del terreno. Si pensava all’abbondanza, quindi a Cerere, quando il terreno era poco fertile e il ricavato era al limite della sopravvivenza; si pensava ad Opi quando la produzione era soddisfacente ed il solo problema era la conservazione. Sono trascorsi più di mille anni, la nostra Opi non ha più dialogo, nessuno le chiede protezione. E’ lontano il ricordo di quando veniva sommersa di spighe di grano e si inebriava dell’odore di queste. Dal suo viso danneggiato, forse proprio a causa del riempimento e svuotamento del pozzo, non si può cogliere nessuna espressione emotiva, spetta a noi interpretare il suo desiderio: cosa bisogna fare? Non si può lasciare nell’oblio per altri mille anni.
PER APPROFONDIMENTI
www.ippolitialessandro.it – vedere Montelanico origini e fondazione e andare dalla pagina 33 alla 40.


.jpg)